Il viaggio che da Marsiglia, in una calda estate di circa trent’anni fa, porta verso l’Occitania conserva un sapore e un odore che non potrà mai essere stipato nella camera dell’oblio.
Fu durante un torneo universitario europeo (molto amichevole) che il mio compagno di studi e di squadra conobbe una dolce presenza che in quel preciso momento pensava di cambiargli la vita.
Benché qualche incombenza universitaria – di quelle per cui si frequenta l’università – chiamasse il pronto ritorno in sede, per osmosi il sentimento di amicizia prevalse davanti al romanticismo di chi fu scosso e non poco da quel dardo così abbacinante.
Durante il viaggio, con la mai doma “pandina”, visto che la meta era la patria della lirica cortese, mi trasformai in Andrè le Chapelain ovvero in un trovatore di poche speranze, cercando di alimentare l’amor cortese del guidatore, sempre più bramoso di raggiungere l’agognato luogo di arrivo.
Fui lasciato al crepuscolo in una piccola brasserie di campagna: compagni fedeli furono il libro di cui all’incombenza universitaria e, di contorno, per quando l’inesorabile sbadiglio avesse preso il sopravvento, una copia di Giganti del Basket e l’Equipe.
Fortuna volle che il luogo ospitante, ad una certa ora, terminato con il servizio relativo alla cena, contravvenendo agli usuali orari transalpini, si tramutasse in una sorta di cocktail bar: la mia solitudine incappò in una coppia di coetanei i quali, forse intristiti dalle mie letture o dalla mia solitaria e paziente attesa del ritorno di Casanova, s’intrattennero fino a notte fonda.
Era un periodo, quello, in cui i giovani d’Europa desideravano conoscere i loro simili di altri paesi del Vecchio Continente: quel muro era caduto da circa un paio di anni e la vitalità, insieme alle note dei musicanti di Dublino, con uno strano nome composto da una consonante ed un numero, aveva una presa vibrante e frizzante su tutti noi.
Quei due ragazzi, erano studenti universitari anch’essi, parlando sui massimi sistemi, cui tre ventenni possono aspirare a discutere, mi fecero conoscere un vitigno, il Cot, gloria locale e mi dissero che questo fosse quello che poi originò il Malbech argentino. Elemento conduttore fu Montaigne: fui fortunato perché lessi qualche passo mesi prima che loro, studenti di filosofia e francesi, apprezzarono; fummo tutti persuasi dal credo del filosofo circa le proprietà che il vino ha sull’uomo, ovvero la capacità di far salire in superficie i più intimi segreti dell’individuo; ponemmo come contro-altare le teorie di Galileo (grande amante del vino) che sosteneva razionalmente come il nettare di Dionisio vada gustato con ragione.
Il loro progetto di vita insieme entusiasmante: Marc, terminati gli studi in filosofia insieme a Emilie, studente ad un’accademia per cuochi, volevano intraprendere un anno sabbatico alla ricerca dell’influenza della gastronomia francese nelle colonie e viceversa; al ritorno oltre che trovare lavoro in qualche scuola egli aveva intenzione di riprendere il vigneto di famiglia, ristrutturare il vecchio fienile e farne un luogo dove la creatività culinaria della sua dolce metà avesse spazio.
Spero tanto che il loro progetto si sia realizzato.
Tornando all’Argentina, durante il mio periodo trascorso laggiù, appena qualche anno prima, laddove il tango è un pensiero triste che balla, avevo sentito parlare del Malbech ma non diedi il giusto peso, complice l’età e i suoi interessi ad essa più consoni. La menzione, dei due commensali d’Oltralpe, ben s’incastonò tra le curve più remote della memoria.
Avevo appena congedato i miei amici di una serata – completato tutte le mie letture, non proprio tutte, diciamo, seduto su una panchina della muta ma piacevole piazza, dove un’insegna verde menta mi prometteva, chissà a che ora, succulenti e meritatissimi pain au chocolat – quando il protagonista del De amore in salsa moderna fece ritorno.
Gli anni duemila non tardarono ad arrivare: il Gualtiero (protagonista della vera opera di Andrè Le Chapelain cioè il De amore) ça va sans dire non vide più la sua Eleonora d’Aquitania (altra protagonista del medesimo racconto), mentre noi siamo ancora amici; nei primissimi anni del nuovo millennio feci ritorno in Sudamerica, complice questa volta una conferenza di lavoro.
Terminati i lavori fummo a trastullarci in un Polo Club vicino Santiago del Cile; colsi la palla al balzo (non quella da polo, per fortuna) allorquando un amico era intento a districarsi su come portare l’auto per il figlio che da lì a poco avrebbe intrapreso degli studi universitari a Buenos Aires. Provenendo dalla capitale dei gauchos, per una pura coincidenza, non ebbi a prenotare il volo di ritorno perché quell’anno, non avendo trascorso vacanze estive volutamente in quanto quel novembre, mi sarei trattenuto un po’ di più nel Paese, che dopo il mio, adoro di più.
Fu cosi che, con un pizzico di baldanza ancora giovanile (era il periodo del trapasso tra la pre-saggezza e la post-saggezza per citare ancora Montaigne) e parimenti di entusiasmo mi proposi di portare quell’auto a Buenos Aires, fermo restando, però, una mia sosta a Mendoza e viciniori.
L’affare fu concluso e così anche il dado fu tratto.
La quiete dei luoghi pervade questo percorso: come ogni viaggio, però, la giusta trepidazione, con il suo misto di affanno, tensione, voglia di scoprire, si confonde con lo spirito che insegue la voglia di conoscenza.
Descrivere le sensazioni nel momento in cui si oltrepassano i paesaggi andini è arduo, trattiene il respiro così come vedere in lontananza la cima del leggendario Aconcagua che allo stesso tempo incute timore, stupore e meraviglia: è davvero tanta l’immensità da restare esterrefatti. Credo che un solo colore dell’inchiostro non declina il giusto tributo a cotanta immensità. La natura in quel contesto desolato ma vitale, fino all’inverosimile, raggiunge il suo apogeo: è il contrasto che si fa maestosità e si rimane increduli a pensare a quanto il Creato ci ha regalato.
Seguire mete programmate o viaggi organizzati non è parte di un’avventura consona al mio spirito; ho sempre lasciato che il mio intuito giochi la sua partita, fuori casa, con l’imprevisto: solo così si può apprendere e lasciarsi guidare dall’ammirazione – che non contempla, ontologicamente, la ragione – che poi rappresenta sin da piccoli il connotato vero di apprezzamento di ogni momento, sia esso una persona o un paesaggio o qualsiasi cosa, che la desta.
Non troppo stremato, decido di fermarmi in un piccolo paesino sulla strada, Villavicencio, non molto lontano dalla mia meta che è la regione intorno a Lujàn de Cuyo: la piccola panaderia sulla strada è accogliente e invitante, il giusto ristoro per meditare le emozioni andine e programmare la mia sosta nell’area dove il Cot è riuscito ad attecchire e a rivivere nel nuovo mondo.
Un buon cortado e delle ottime medialunas mi aiutano a fare la conoscenza con un altro avventore: Carlito mi dice subito delle sue discendenze italiane, non è mai stato nel Belpaese e i suoi racconti dell’Italia sono i racconti che gli facevano i suoi nonni; quanta poesia tra le reminiscenze di questo piccolo e garbato personaggio; mi racconta di come benché abbia studiato economia il suo sogno è quello di diventare un enologo perché ama il suo territorio.
Appreso della mia visita si offre subito di farmi da cicerone; la sua è un’offerta spontanea, non cela la richiesta di danaro ma mi rammenta, però, che gli piacerebbe gli rendessi il favore: arbitrare la partita di calcio che nel pomeriggio si disputerà e partecipare all’asado che d’appresso si consumerà con un gruppo di suoi amici.
Il mio blazer d’ordinanza e un paio di bermuda riescono a essere il giusto tributo alla figura dell’arbitro d’antan: un paio d’imprecazioni su decisioni dubbie le meritai ma l’esperienza fu encomiabile così come il buon asadito finale, nonché la vecchia ma ben curata pensione dove sostai.
Il giorno seguente, Carlito mi attende per il suo giro perlustrativo dell’area e mi racconta della storia del Malbech.
La leggenda narra che fu l’enologo francese Miguel Peoget a portare alla fine del mondo quel vitigno che in Francia pativa per la filossera sospinto anche dalla missione dell’allora presidente Sarmiento a voler dare impulso all’industria vitivinicola.
Il mio conduttore ha comunque una sua teoria: infatti alcuni vitigni sono dei malbech di origine friulana (che da queste parti ha accolto una grande emigrazione compreso i suoi antenati) innestati con altri di origine ungherese. Non posseggo gli strumenti per obiettare a tale teorie ma i vini assaggiati sono semplicemente strepitosi: eleganti, intensi si dipanano nel palato con strepitosa morbidezza.
Il suo colore è scuro, molto denso, caldo e direi ipnotico e l’altitudine dove cresce e regala tali sensazioni è senza dubbio una ricchezza ed anche una esclusività.
Il viaggio intorno a questi luoghi e con un presentatore d’eccezione fanno di questa esperienza un ricordo indelebile. Mi congedo da Carlito senza prima avergli strappato un’ulteriore promessa, ovvero l’invio di musica italiana degli anni Sessanta.
Intraprendo il mio viaggio verso la Capitale: è sublime pensare a quante emozioni l’incontro con altre persone può regalare; questo racconto di vite e di viti parte da lontano per poi intrecciarsi con un unico filo conduttore, antropologico e naturale: forse è proprio vero che la vite ha accompagnato la vita dell’uomo nel suo migrare, in un unico sodalizio che semanticamente s’intreccia e regala i suoi frutti come l’uomo riesce a donare alla propria vita il frutto della sua esperienza, un unico grande, immenso, contorto e per questo splendido e affascinante viaggio.
* In copertina immagine tratta dal sito di Cheval des Andes.

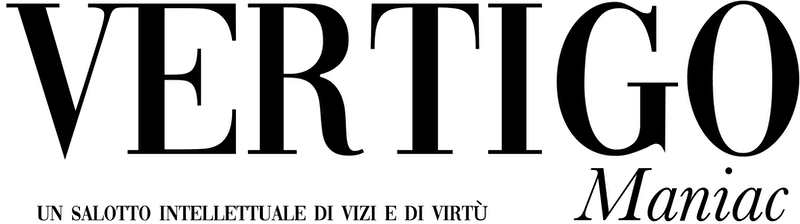

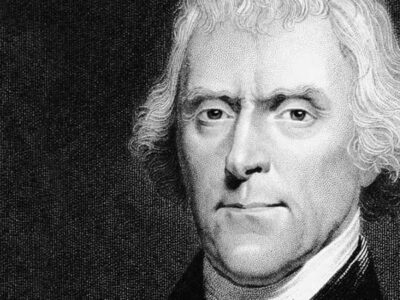






Commenti