questo racconto è stato scritto anni prima dell'uscita di Io capitano, di cui l'autore ha scritto qui
Sei sveglio da venti minuti quando l’orologio che hai al polso inizia a suonare.
Lo spegni, controlli l’ora e ti alzi. Sei abbastanza cosciente da sapere che sarà l’ultima volta che metterai piede sul quel pavimento, ma allo stesso tempo ti rifugi nel torpore della routine del risveglio per non assecondare fino in fondo tale pensiero. Prendi un profondo respiro, ti passi le mani tra i capelli e senti il freddo del pavimento avvolgerti i piedi scalzi. Non è una sensazione sgradevole. La accetti e abbassi le mani. Accettare di toccare il pavimento coi piedi nudi equivale ad accettare che la giornata è realmente iniziata. E che realmente proseguirà secondo l’itinerario che ti sei ripetuto decine di volte durante la notte. O così speri.
Attorno a te l’aria è viziata e la camera è quasi del tutto buia. A illuminarla c’è solo il contorno di luce che filtra dalla finestra. Sudore e polvere sono mischiati nella medesima percentuale e ne cogli l’aroma pungente a ogni respiro. Vai alla finestra. Sposti la tenda logora che ti separa dal mondo per sbirciare le realtà estranee alla camera. La luce ti stordisce, ma passa in un attimo. Dal secondo piano del palazzo in cui ti trovi hai una buona visuale della città. Non vedi scorrere molte auto – ne conti undici – e non vedi nessuno camminare. Il giorno sta prendendo piede.
Te ne compiaci, tiri la tenda e vai a sederti sul letto. Trovi il materasso scomodo come quando lo hai lasciato pochi minuti prima e pensi che è la ragione per cui hai dormito quattro ore. Ma sai che è una verità parziale. Avevi altro a cui pensare. Guardi l’ora. Le 06:27. Ripensi a quando hai rubato l’orologio al turista tedesco un mese prima. Si era perso. Fu troppo facile quando ti chiese le informazioni per tornare in centro. Lo distraesti, afferrasti l’orologio e corsi a casa, quattro chilometri fuori il perimetro della città. Ti sembra sia passata un’eternità, invece sono trascorsi 30 giorni e 1500 km.
Non hai appetito ma ti dirigi in cucina per fare colazione. Trovi la tavola come l’hai lasciata la sera prima: spoglia, eccezion fatta per il pentolino al centro. Ti avvicini, lo agguanti e cominci a mangiare gli avanzi di shorba. La assapori lentamente e comprendi d’aver messo troppo peperoncino. Sarebbe una buona scusa per non mangiare, ma avrai bisogno di energie, così la finisci. Ti pulisci la bocca sul braccio e metti il pentolino in un buco da cui pende una canna di gomma verde. Qualcuno lo laverà. O forse no. Non importa. Tra poco non sarà più un tuo problema. Bevi un sorso d’acqua direttamente dalla canna ed esci dalla cucina. Guardi l’ora. Le 06:48. Ti dirigi in bagno e ti prepari velocemente. Anche se passeranno a prenderti tra mezz’ora vuoi sbrigare quell’incombenza il prima possibile. Dopo esserti sistemato, torni in camera e ti risiedi sul letto. Se fossi a casa riassetteresti le lenzuola, ma non lo sei e non le hai trovate rifatte al tuo arrivo. L’odore di sudore torna a pungerti le narici e per la prima volta consideri la possibilità che non sia solo frutto del tuo corpo. Viste le circostanze che ti hanno portato lì, il locale potrebbe essere stato usato da decine di persone prima di te, così come potrà essere usato da altrettante decine dopo di te, senza che nessuno lo abbia pulito. Sorridi al pensiero della parola “dopo”. Per tutta la notte ti sei preoccupato di ciò che sarebbe accaduto dopo che avresti lasciato quelle stanze, e ora pensi per la prima volta a ciò che c’è stato prima.
Il sorriso svanisce alla vista dell’orologio. Le 07:09. Ti vesti, allacci le scarpe ed estrai il vecchio zaino coi ricambi da sotto il letto. Ne avrai bisogno.
Esci dall’appartamento lanciandogli un’ultima occhiata. La carta da parati mezza marcita e la nudità delle due camere che lo compongono ti suscitano tristezza, eppure, nonostante tu lo abbia visto per la prima volta la sera prima, sei certo che ti mancherà anche se non ne conosci il motivo. Chiudi la porta assicurandoti che sia bloccata, come ti hanno detto di fare, scendi le scale e ti affacci in strada. Il traffico ha aumentato di consistenza e una quindicina di persone passeggiano su ambo i lati del marciapiede. Le osservi incuriosito. Ti chiedi come impiegheranno la loro giornata e sei abbastanza sicuro di capirlo da come camminano. Immagini quali possano essere le loro vite il tempo necessario per tornare a ciò che aspetterà te. Ma al contrario dei passanti, non sei più sicuro di come andrà la tua giornata. La paura che a fatica hai scacciato durante la notte comincia a ribollirti nelle budella, e devi fare appello a tutte le forze mentali che possiedi per non andartene. Fai un profondo respiro e razionalizzi la cosa. Scappare non servirebbe. Verresti trovato prima ancora di rincasare e se anche rincasassi non troveresti nulla ad aspettarti. Anche per questo hai deciso di provare.
Alzi la testa e guardi il sole illuminare il contorno dei palazzi. Gli edifici che ti circondano e la respirazione rallentata aiutano a calmarti. Hai tenuto a bada la paura, benché non sapere in che via ti trovi – nessuno ti ha informato a riguardo – non aiuta a sentirti stabile.
Soffia una leggera brezza e respiri la salsedine che proviene dalla costa. Riconosceresti quell’odore ovunque, sei cresciuto vicino al mare, e ripensi a come hai incontrato quell’odore la prima volta, assieme a tuo padre.
Guardi l’ora. Le 07:17. Tra poco passeranno a prenderti. In un angolo della mente assapori l’idea che ciò non accada, ma sai che non andrà così.
La temperatura è mite – sui 13° – ma da lì a qualche ora raggiungerà i 25°. È un bene che sia il 20 aprile e non il 21 luglio. Se fosse estate, suderesti troppo e arriveresti a fine giornata stremato.
Pensando al tempo ti guardi attorno, e cerchi il nome della via in cui ti trovi. Ti domandi come sia possibile che una città con oltre un milione di abitanti non abbia dato il nome a una via. La sensazione di instabilità torna a farsi sentire. Questa volta, però, non provi paura ma consapevolezza. Consapevolezza che vorresti sapere il nome di quella via e che avresti voluto più tempo per scoprirlo. È pur sempre la prima volta che ti trovi lì. Invece di tempo non te n’è stato concesso e questa è l’unica cosa che ti resta.
Sei arrivato la sera prima e non ti sei mosso dall’appartamento. Ti hanno detto di aspettare rintanato in casa fino al giorno seguente, e così hai fatto. Hai visto le luci della città mentre raggiungevi il bilocale e hai osservato dalla finestra il viavai della vita che ti stava attorno, ma non sei uscito. Avevi paura e troppo da perdere.
Mentre rifletti, una jeep si affianca al marciapiede. È un’auto vecchia, color verde militare sbiadito, un veicolo inadatto a viaggiare in città ma funzionale per percorrere tratte desertiche. Guardi il mezzo con sospetto, restando immobile. Il finestrino si abbassa e un uomo ti scruta. È un tizio sui 40 anni, sovrappeso, calvo, con la fronte imperlata di sudore e una sigaretta all’angolo sinistro della bocca. Dalla tasca frontale della camicia estrae un fazzoletto e se lo passa sulla testa bagnata e sulle guance ispide.
«Ehi», ti dice, «devi andare a pesca?»
Rimani immobile, deglutisci un sorso di saliva e ripeti nella mente la domanda che ti è stata posta. È il segnale.
Annuisci.
«Allora muoviti. I pesci non aspettano.»
Ascolti le parole come un’eco. Eppure sono pronunciate a meno di cinque metri da dove ti trovi. La strada sembra bloccarsi. Ci siete solo tu, il ciccione e la jeep. Resti fermo contemplando ciò che hai di fronte e proprio mentre l’uomo sembra sul punto di parlati gli vai incontro mordendoti il labbro.
Entri in auto non dicendo una parola e vieni accolto dallo stesso silenzio. L’abitacolo è grande a sufficienza per ospitare tre persone, eppure ti sembra troppo piccolo a causa del guidatore.
L’uomo parte senza curarsi di te e in cuor tuo gliene sei grato. Ti ha dato l’impressione d’essere un soggetto sgradevole, e l’odore di uova marce che stai respirando lo conferma. Abbassi il finestrino per cambiare l’aria e torna a prendere consistenza la realtà che ti sta attorno. Sei in auto, stai per affrontare quello che ti aspetta e sei solo. Il cuore ti batte a velocità aumentata e la paura risale dai meandri dell’intestino. Riprovi il trucco della razionalizzazione, ma non funziona. Ti concentri sulle case che scorrono alla tua destra. La loro vista dà ulteriore conferma che sta succedendo quello che fino a poche ore prima avevi solo immaginato. Ma dopo cinque minuti la paura torna a stabilizzarsi, e da limitante diviene stimolante. Due settimane fa eri in balia del nulla; ora, in meno di 24 ore, sarai in un altro continente e potrai avere qualcosa di tuo. O semplicemente qualcosa.
Ti ridesti quando scorgi il cartello che avverte l’uscita dalla città. È a 200 metri da voi. Provi un misto di rabbia ed eccitazione, come la sera prima. L’autista rimane chiuso nel proprio silenzio. Di certo lui saprà il nome della via in cui ti è venuto a prendere. Ma benché oltre cento km vi separino dal traguardo, non hai intenzione di chiedergli nulla.
Superate il cartello che annuncia il confine perimetrale della città. Dallo specchietto retrovisore le lanci un’ultima occhiata. Non la rivedrai presto. Probabilmente mai più. Allontani la malinconia lasciandoti colpire dall’aria che entra dal finestrino. L’odore di salsedine è ancora presente e ti distrae dal puzzo del compagno di viaggio. Dopo un paio di minuti riguardi lo specchietto. Tripoli è scomparsa. Non vuoi abbatterti. Ma non ci riesci.
Il viaggio è silente.
Il tuo compagno tiene lo sguardo fisso sulla strada e finisce un intero pacchetto di sigarette. Il fumo non ti piace, lo hai detestato fin da bambino, ma non gli dici di limitarsi. Si ferma due volte per pisciare, e anche in quelle occasioni non parla. Nemmeno ti chiede se devi farla. Sei fortunato, non ne hai bisogno. Ti basta avere il finestrino aperto e guardare il paesaggio che si presenta ai tuoi occhi. Osservi le poche abitazione sparire al vostro passaggio con curiosità, e pensi che sarebbe bello provare le stessa cosa per quello che ti aspetterà.
Guardi l’ora. Le 08:36. Il sole è alto e il caldo è aumentato. Se non avessi il refrigerio dell’aria staresti sudando più di quanto già non stia avvenendo. Un cartello indica Zuara. Torni a fissare il paesaggio. Sabbia e case si alternano in modo irregolare. Pensi alla scelta di parole che ti hanno portato a salire su quella macchina. Andare a pesca. Vorresti che tuo padre fosse lì per dirgli che finalmente tornava utile aver fatto un lavoro che detestavi.
Quando sei salito la prima volta su una barca avevi quattro anni. Non ricordi come trascorresti la giornata, ma sai come si concluse: vomitasti. Era la prima volta che affrontavi il mare. Non saresti più voluto rimontare su un natante, ma tuo padre ti obbligò a salirci di nuovo, due giorni dopo. E da allora il mal di mare passò. O questo è quello che ti ha raccontato Fadwa, tua madre. Non sei mai stato sicuro di aver superato il rifiuto del mare. Ancora adesso, ogni volta che sali su una barca, impieghi un paio di minuti per assestare la nausea. Ti hanno detto che è normale per tutti i pescatori, soprattutto quando sono giovani come te. Non hai indagato a fondo la cosa. Non ne hai avuto il tempo. Quando a tredici anni tuo padre è morto e hai dovuto affrontare il mare da solo, hai imparato che nauseante o meno il mare era quello che ti aspettava. Tua madre era fiera di vederti abile in quello che era stato il lavoro che aveva dato sostentamento alla famiglia, ma a te non piaceva. Non amavi svegliarti all’alba ogni giorno, arrivare alla spiaggia già stanco, ammazzarti di fatica e tornare alla baracca di lamiere in cui vivevi; non amavi armeggiare con reti e ami di cui non capivi nulla; non amavi prendere il largo sulla barca che tuo padre aveva tanto adorato, ma che per te non era altro che un ammasso di legno marcito; non amavi il pesce, che da quando hai memoria ti è indigesto; e non amavi vedere il compiacimento sul volto di tua madre, così fiera che il primogenito maschio fosse divenuto come il padre. Non potevi dire a Fadwa che restare con lui ti faceva sentire vulnerabile perché il vecchio non sapeva nuotare – verità che trovavi inquietante e ridicola allo stesso tempo. E soprattutto non potevi dirle che quando dovesti prendere sulle spalle le sorti della famiglia, sentivi d’essere stato privato della possibilità di vivere una vita che fosse tua. Non potevi parlare perché non avrebbe capito. Era troppo impegnata a crescere tua sorella Alina e tu a non darle dispiaceri.
Ma adesso tutto quello che avevi passato tornava utile: non avresti vomitato durante la traversata di quella sera.
Avvisti un cartello che annuncia l’entrata a Zuara tra quattro km.
Ti prepari alla vista delle case, ma la jeep sterza bruscamente a destra, cento metri dopo il cartello, e ti ritrovi su una strada dissestata in mezzo alla sabbia. Ti aggrappi allo sportello. Il brusco movimento è repentino e ti dà un colpo al fianco. Vorresti chiedere dove state andando, ma desisti. L’autista non decelera, quindi il tuo stomaco percepisce un pugno ogni buca che il selciato vi riserva. Gli ammortizzatori fanno del loro meglio, ma non basta. Pensi che è come stare in mare, e stai peggio. Trattieni un conato e ti aggrappi alla cintura. Proseguite per un chilometro, fino a quando non avvisti il mare. Non sai se sentirti consolato o impaurito. Nell’indecisione ti concentri sulla nausea. Dopo altri cinque minuti di buche e sassi, imboccate una strada laterale a sinistra. Non è asfaltata, ma è cosparsa di una gettata di cemento che ne favorisce la circolazione. Ti chiedi perché sia in quelle condizioni mentre la precedente no. Lasci perdere. Non è del suolo che dovrai preoccuparti. Dopo mezzo chilometri scorgi il mare. È una riga azzurra che si presenta ai tuoi occhi come una visione. La osservi attentamente, fino a quando non ti accorgi degli ammassi in legno che sorgono sparsi dalla sabbia. Capisci con un colpo d’occhio di che si tratta: relitti di barche. I primi cinque li osservi come semplici constatazioni; dal sesto cominci a studiarli. Quattro hanno lo stesso colore della barca sulla quale pescavi – azzurro. Abbassi lo sguardo per non abbatterti, ma non resisti. La nausea aumenterebbe. Rialzi gli occhi. Proseguite per altri dieci minuti, avvicinandovi sempre più alla spiaggia. Vi arrivate e la jeep si ferma con una frenata brusca. Smonti senza dire una parola e sei ricambiato. Appena appoggi i piedi a terra, prendi una boccata d’aria che calma il disastro nelle budella. Ti compiaci della salsedine e guardi l’ora. Le 09:12. Il sole ti abbaglia e il caldo ti colpisce alla testa. Lanci un’occhiata al tuo compagno di viaggio per capire che fare, ma quello si accende un’altra sigaretta, estrae un telefono e fa una telefonata. Lo lasci perdere, avvisti una palma a cento metri da voi, prendi lo zaino col ricambio e ti incammini. Appena raggiungi l’albero, l’ombra delle foglie ti fornisce un attimo di tregua dal caldo. Ti siedi appoggiandoti alla sacca e respiri lentamente. È l’unico albero nel tratto in cui ti trovi. La spiaggia è lunga cinque chilometri. Tu ne puoi vedere solo due. Non ti guardi attorno. Sei molto stanco. Ti copri il viso accoccolandoti, chiudi gli occhi e ascolti lo scrosciare delle onde. Il suono ti rilassa e calma le viscere. Ripensi ai relitti lungo la strada. E vorresti tornare sulla jeep.
La voce del bambino ti sveglia di soprassalto.
Il sole ti colpisce gli occhi e senti la fronte madida di sudore. La scarica di adrenalina passa. Allunghi le gambe, sbadigli e tieni gli occhi chiusi. Quando le funzioni del corpo si riassestano, guardi l’ora. Le 10:04. Tasti la maglietta. È fradicia, come il resto del corpo. Di fronte a te, a mendo di trecento metri, il bambino corre attorno a una donna che con molta probabilità è sua madre. A destra tre uomini stanno affiggendo delle travi in legno a una barca. Non sai da dove siano sbucati. Escluso te e il tuo compagno, sono gli unici esseri umani sulla spiaggia. Il ciccione è ancora seduto in macchina, fuma una sigaretta e sbraita al telefono. Pensi di andare a chiedergli quando ti muoverai ma rinunci, così osservi la donna col (presunto) figlio. Sono in netto contrasto con gli uomini al lavoro sulla barca. Lei e il piccolo sono di carnagione scura, parlano un misto di inglese e tigrino e indossano abiti sgargianti di color arancione e verde; i tre lavoratori sono di carnagione olivastra, parlano arabo e sono vestiti con magliette chiare e calzoncini blu e marroni. Il bambino sembra avere cinque anni. Salta e urla attorno alla madre che, visibilmente stanca, tenta di calmarlo rifiutando di prestarsi agli schiamazzi. Tiene gli occhi bassi. Non ne cogli alcuna gioia e ti sembra che l’occhio sinistro sia cerchiato da un’ecchimosi. Non la scorgi con precisione. Ti chiedi se li vedrai anche stasera. Ti hanno detto che al momento della partenza le persone a bordo dell’imbarcazione superano più del doppio la capacità di portata. Facilmente potresti non vederla, mischiata alle altre centinaia di sconosciuti. O semplicemente potresti non vederla perché nessuno dei due arriverà a destinazione, eliminando ogni occasione di incontro. Il pensiero ti impaurisce e lo allontani scuotendo la testa. Pensi possa non essere una tua compagna di viaggio ma una semplice donna che ha portato il figlio (o chiunque sia il bambino) in spiaggia. In fondo il ritrovo sarà non prima delle 23:00. Ma ti pare improbabile che la donna sia lì per una giornata balneare.
Osservando i due giocare non ti accorgi che il tuo compagno si sta avvicinando alla palma. Alzi lo sguardo e lo vedi camminare a passo lento. Si copre la testa con la mano sinistra e con l’altra si massaggia la pancia. Il bordo inferiore della maglietta lascia intravedere un profilo di epidermide villoso. Ti disgusta. Appena ti raggiunge si mette all’ombra, stando in piedi, e prende fiato.
«Dunque?», dice ansimando.
Scrolli le spalle. Lui tossisce, sputa per terra e si passa una mano sulla bocca.
«Lo vedi, là in fondo?», chiede indicando uno scafo coperto da un telo, dietro di te.
Ti giri e annuisci. Non lo avevi notato prima.
«Useranno quello per raggiungerti. Ti hanno detto che è alle 23:00?»
Annuisci di nuovo. L’uomo se ne compiace e torna alla macchina senza aggiungere altro. Mubin, tuo zio, ti ha ripetuto l’iter venti volte.
Era venuto da te di sabato pomeriggio, due settimane prima, per parlare di “certi affari familiari”. Essendo tu il capo famiglia aveva chiesto che tua madre e tua sorella non ci fossero. Non accettasti. Alina poteva uscire; Fadwa no. Tuo zio chiese come andasse l’economia domestica e come ve la cavaste. Rispondesti con frasi di circostanza, infastidito dall’inutilità delle domande. Tuo padre era morto da un anno e quella era la prima volta che tuo zio si faceva vedere. Fadwa, invece, sembrò felice di parlargli – era pur sempre suo fratello. Dopo quello che ti parve un preambolo ben costruito, Mubin disse d’aver ricevuto una lettera la settimana prima. Sei mesi dopo il funerale, spiegò, era stato disposto un controllo catastale per il passaggio di proprietà della casa in cui vivevi. Essendo minorenne, ed essendo tuo padre l’unico maschio, il passaggio doveva effettuarsi nei confronti di Fatwa. Ma ero emerso che la casa non era registrata al catasto. Mubin fece una pausa e guardò tua madre. Fatwa non disse una parola. L’uomo voltò gli occhi su di te. Restasti immobile. Non sapevi cos’era il catasto. Tuo zio disse di aver ricevuto la lettera in quanto parente maschio più prossimo all’ex proprietario. Nella lettera era scritto che da lì a un mese dovevate giustificare la mancata registrazione, presentando in municipio la documentazione catastale. In caso di mancata presentazione le possibilità erano due: pagare una multa pari all’ammontare del valore della casa; incorrere nel sequestro della dimora – che a tutti gli effetti risultava abusiva. Mubin chiese alla sorella se poteva fornirgli i documenti. Fadwa iniziò a piangere. Capisti che nemmeno lei sapeva cos’era il catasto. Rivolse a te la stessa domanda. Non rispondesti. Passarono cinque minuti in cui non diceste nulla. Solo i singhiozzi di tua madre riempirono la stanza. Tuo zio si alzò e disse che doveva andare, ma che si sarebbe fatto risentire. Fadwa gli chiese che cosa potessero fare. Non ebbe risposta. Prima di uscire, l’uomo ti chiese di accompagnarlo alla macchina. Quando arrivaste allo sportello, fosti informato che c’era un’alternativa al sequestro. Entro due settimane ci sarebbe stata una traversata dalla Libia. Il traghettatore – così lo chiamò Mubin – era morto in un incidente d’auto il giorno prima. Serviva qualcuno che avesse esperienza di navigazione e che fosse facilmente confondibile tra i migranti, una volta giunti a destinazione. Se accettavi, una volta sbarcato saresti andato a Milano. Lì avresti trovato un amico di tuo zio per il quale avresti lavorato. Mubin avrebbe anticipato i soldi per il catasto e tu glieli avresti restituiti lavorando. Cosa avresti fatto e come si sarebbe realizzato ciò che ti proponeva una volta in Italia, non venne precisato. Chiedesti come faceva a sapere che ci sarebbe stata una traversata. Rispose che non era un tuo problema, e che dovevi scegliere in quel preciso momento. Abbassasti la testa e sentisti la paura prenderti le budella. Ti portasti una mano agli occhi e chiedesti come avresti pagato la traversata. Mubin rispose che se avessi condotto la barca non avresti pagato; se ne sarebbe occupato lui. Guardasti le lamiere arrugginite nelle quali vivevi. Alina era rientrata in casa. La sentisti parlare con tua madre. Fadwa aveva la voce roca, ma camuffò lo stato d’animo di poco prima. Tornasti a guardare tuo zio. Si era accesso una sigaretta e ti osservava in attesa di una risposta. Il caldo era soffocante, sebbene fossero passate le 19:00. Mubin sudava copiosamente. Chiazze scure avvolgevano le ascelle della camicia azzurra, e gli rigavano il volto rasato. La paura continuava a farti rodere le viscere, ma per la prima volta si stava concretizzando la possibilità di andartene. Non come l’avevi immaginata – anche se non l’avevi ancora concretizzata in una scelta precisa –, ma l’occasione di vivere una vita tua era lì. Accettasti. Mubin sorrise, spense la sigaretta e disse che sarebbe tornato due giorni prima la traversata per spiegarti come e cosa avresti fatto. Intanto sarebbe stato ottimale che ti fossi esercitato più che potevi con la barca. Prima di andare, gli chiedesti di mostrarti la lettera del comune. Non rispose. Quando partì ti sentisti stupido e spiazzato. Formulasti l’idea che la storia del catasto fosse una menzogna per ricattarvi. Ma passò in secondo ordine al pensiero che avresti potuto vivere la vita che ti spettava. Mentre tornavi in casa pensasti a tua madre e a tua sorella. Provasti vergogna e paura per il fremito che ti prendeva la testa all’idea di andartene. Ti sentivi in colpa perché eri frastornato e felice. Ma poi tornasti a tutte le mattine in cui ti eri alzato ed eri andato al lavoro, a tutte le volte in cui non ti eri lamentato della condizione in cui vivevi, e il senso di colpa passò. Due giorni dopo Mubin si rifece vivo e ti spiegò quello che avresti fatto: il giorno prima della traversata ti avrebbe accompagnato a Tripoli, dove avresti alloggiato in una casa usata abitualmente per quel tipo di soggiorno – così si espresse. Il giorno seguente saresti andato a Zuara, e una volta lì avresti aspettato un altro autista che ti avrebbe condotto in Tunisia, in un villaggio vicino a Ben Gardane, a quaranta km dalla costa. Mubin ti avrebbe fornito i documenti necessari per passare il confine libico e tunisino. Dalla Tunisia avresti preso il largo e avresti aspettato l’arrivo dei migranti a sessanta km da Zuara. In questo modo avresti aggirato i controlli delle autorità navali. Da quel momento saresti stato solo e avresti condotto la barca fino a Lampedusa. Avvistato dalle motovedette ti saresti mescolato tra i migranti e saresti stato dirottato al centro di accoglienza. Tre giorni dopo l’arrivo saresti stato contatto da un amico di tuo zio di nome Nibras. Ti avrebbe fatto uscire e poi sareste andati a Milano, dove avresti preso contatto con Mubin. Non dovevi preoccuparti di come sarebbe avvenuto. Lo avevano già fatto. Dovevi solo assicurarti di arrivare in Italia salvo. Tua madre e tua sorella dipendevano da te, ed erano fiere di quello che stavi per fare. Sentendo quella precisazione ti fu chiaro che eri al centro di un ricatto. Ma non ti importò. Potevi andartene.
Ti alzi dalla palma e ti dirigi allo scafo.
Sono le 10:30 e il caldo è aumentato. Ti proteggi il volto con le mani. La donna e il bambino si sono allontanati. Sono seduti all’ombra di un vecchio peschereccio marcito. Il piccolo dorme sulla spalla della giovane. I tre uomini se ne stanno seduti all’ombra della barca che riparano. Bevono una sostanza verde da bottiglie di plastica logore. Il tuo compagno è in auto, al telefono. Nessuno si cura di te. Raggiungi l’imbarcazione e la osservi. Alzi il telo. È un vecchio Zodiac 390. Il motore è un Evinrude G2 300-HP, lo stesso della tua barca. Il mezzo è più piccolo di quanto pensassi. Non sai stimarne la lunghezza, ma sei sicuro non possa contenere più di 15-20 persone. Ti sembra ragionevole contando che dovrà muoversi con discrezione. Passi le dita sulla gomma sbiadita. Se dovessero essere trasportate 20 persone alla volta, l’imbarcazione dovrebbe essere grande almeno il doppio. Ma non escludi che la barca che condurrai non sarà più grande di quella che hai di fronte.
Mentre stai studiando il motore vieni raggiunto da un fischio. Il ciccione ti fa segno di raggiungerlo. Ti incammini a passo svelto, arieggiandoti con la maglietta sudata. Lanci uno sguardo agli uomini e alla donna col bambino. Nessuno ti guarda. Appena arrivi alla macchina vieni raggiunto dal puzzo di sigarette e sudore. Ti copri il naso fingendo di dover starnutire.
«Mohamed arriva tra mezz’ora. Ti porterà alla barca.»
Resti immobile.
«Ascoltalo e non ci saranno problemi.»
Vi guardate per qualche secondo, in silenzio, poi lui riceve una telefonata. Cogli l’occasione per andartene. Raggiungi di corsa la palma, ti siedi e abbracci la sacca col ricambio. La stringi al petto, sentendo la pelle riscaldarsi. Provi un senso di abbandono e solitudine che non ti avevano mai colpito prima. Vuoi piangere, urlare e scappare. Ti guardi attorno per trovare un appiglio che possa toglierti la paura che ti è esplosa nel cervello. Non lo trovi.
Nascondi la testa, mordi un lembo della stoffa e delle lacrime copiose cominciano a rigarti le guance. Non le blocchi, ma non ti lasci andare alle urla. Singhiozzi dondolandoti in avanti e indietro. Poi alzi la testa. Lo sguardo è annebbiato dalle lacrime e dal caldo. Osservi il tuo compagno di viaggio e ripensi a quello che ti ha detto.
Mohamed era il nome di tuo padre.
...segui Gianpietro.
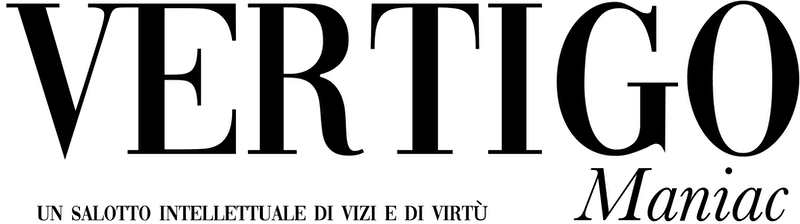


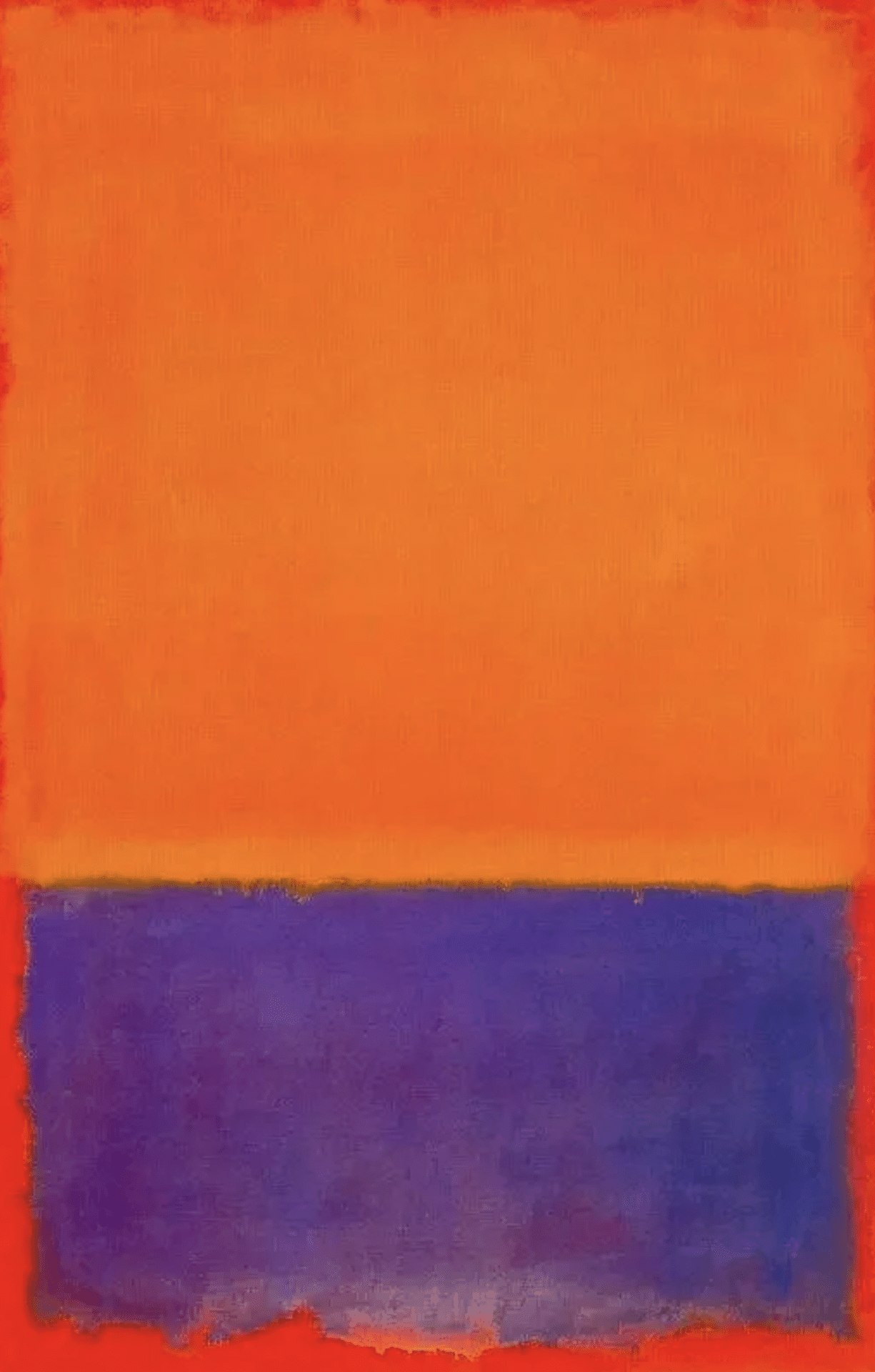








Commenti