Quando venne scoperto, nel 1799, l’ornitorinco destabilizzò l’equilibrio della comunità scientifica e accademica internazionale.
Sessantaquattro anni prima uno scienziato di nome Carl Nilsson Linnaeus, Linneo per gli amici, aveva inaugurato una serie di trattazioni che culminavano in una codifica totale dei regni animale, fungino e vegetale, classificati secondo l’alberatura dei generi e delle specie. Si trattava della cosiddetta nomenclatura binomiale, una catalogazione universale che organizzava in maniera sistemica lo scibile umano servendosi della tassonomia istituita, all’uopo, proprio da Linneo.
Fu quello il momento culminante dell’Illuminismo: l’opera di battesimo delle cose del mondo incominciata agli albori dell’umanità era giunta a compimento. Finalmente codificato e così ordinato il mondo faceva meno paura: ogni cosa aveva un ordine e un posto, l’Illuminismo si apprestava a lasciare il posto al Positivismo e tutto si sarebbe consumato nel più pacifico e compiaciuto dei modi se non fosse stato, appunto, per l’ornitorinco.

L’animaletto australe, infatti, con la sua semplice, innocente evidenza smentiva tutto l’immane lavoro di denominazione – e dominazione – dell’uomo. Esso apparteneva a tutte le famiglie animali e, allo stesso tempo, a nessuna: come i mammiferi vantava una pelliccia, aveva sangue caldo e allattava i suoi piccoli; piccoli che, tuttavia, deponeva in uova alla stregua di un oviparo mentre col mondo dei rettili il maschio della specie condivideva un veleno che secerneva da un becco che, a una più accurata analisi, si scoprì poi essere un sonar per buona pace di Winston Churchill.

Come se non bastasse, l’ornitorinco aveva tutte e quattro le zampe palmate degli uccelli benché incastonate in un corpo di lontra… In un unico essere, insomma, il caos di ogni velleità tassonomica nonché la fine di ogni umana certezza. Sipario!
La Vernaccia di Oristano e l’ornitorinco
Precisamente tutta questa vicenda, appresa all’epoca dei miei studi di Semiotica Interpretativa, mi è tornata in mente davanti al primo calice di Vernaccia di Oristano.
Incidentale, invero, il fatto che si trattasse di un esemplare del 1968 di Silvio Carta. Non incidentale, invece, la sua natura: vinosa e allo stesso tempo spirituale in limine com’era tra il mondo dei fermentati, quello dei liquori e quello dei distillati, benché senza distillazione. Ebbene, strabuzzai gli occhi quando appresi che, per la vulgata comune, la Vernaccia di Oristano rientrava nella categoria di un vino DOC come un vino comune: mi sembrò chiaro, in quel momento, che la comunità accademica aveva rinunciato all’idea di creare una categoria a parte per un vino che, del vino, invero, e secondo quanto si scrive nei libri di testo, riportava il difetto per antonomasia: il pollice verso plenario, la stigma, l’onta dell’ossidazione.
L’ossidazione è, difatti, la sua caratteristica più evidente, e lo costituisce al punto da snaturarlo in qualcosa di radicalmente diverso: non più vino né già spirito. Eppure non si tratta di un vino tecnicamente ossidato, come il Marsala, piuttosto, qui è la fermentazione a giocare un ruolo essenziale e diversissimo, costituendo un unicum nel panorama enologico nazionale e oltre. Nel calice, difatti, volteggia un elisir che spariglia le carte di qualunque classificazione e in cui l’alcol o, meglio, la glicerina assieme a una nebulosa, penetrante sensazione di ossidazione che tale, tuttavia, non è, ne rende ineffabile la definizione se non attraverso la sospensione, o la smentita, di tutto quello che, sul vino, abbiamo sempre creduto di sapere. Ma cominciamo dall’inizio.
Mi ero già invaghita della Riserva 2004 dello stesso produttore poche ore prima: appunti alla mano: “Un elisir nobilmente speziato in cui tutte le polveri dell’Oriente sembrano nebulizzarsi in un effluvio di agrumi e olii di frutta secca, preconizzando un sorso terso ma ricco, teso di sale e fresco di frutto benché nella cornice, apparentemente inconciliabile e contro-intuitiva, di un’ossidazione totale.” Allo stesso modo accadde, inesorabilmente, con la 2001 nel suo snocciolarsi di noci, semi e visciole e un etereo graffiante e infantile, simile al ricordo dell’odore della Cristal Ball ma su una bocca felpata: un guanto sapidissimo e strutturato, immateriale e lunghissimo, proiettato in un agone tra carrube e china, tra china e carrube e di nuovo noci e sale, ricorsivamente.
Ma dovevo arrivare alla 1968 per capire cosa della Vernaccia di Oristano mi riportasse all’ornitorinco dei miei trascorsi accademici. La 1968 segnò infatti per Silvio Carta l’anno dell’ultima vinificazione nella storica sede di Baratili San Pietro, nonché l’anno dell’ultima vendemmia scalare. Secondo gli annali, si trattò di un’annata così straordinaria da restituire una “Vernaccia assoluta” secondo le stesse parole di Elio Carta che confessa come “complice la vinificazione, sia diventata immortale“.
Questa vinificazione incomincia infatti con la fermentazione in legno di castagno dove avviene un fenomeno chiamato ossigenazione di scambio a una temperatura di 46-48°C: una temperatura proibitiva che farebbe impallidire, letteralmente, qualunque vino ma che alla Vernaccia di Oristano consente, ancora una volta contro-intuitivamente, di fissarsi se non per sempre comunque ben oltre il lasso di una generazione. È questa temperatura di gestazione a permetterle di sopravvivere al caldo e, sopratutto, al tempo e di trasformarsi in quella sorta di Benjamin Button del vino che più va avanti e più s’esalta, quasi ringiovanendo.
Va da sé che questo tempo impone dei costi che sono, essenzialmente, costi produttivi enfatizzati ulteriormente da una consistente perdita fisiologica: Elio Carta ci spiega che dei 64.500 litri di vino della 1968 furono ricavati appena 3000 litri di Vernaccia di Oristano: i restanti 61.500 sublimarono in quella sorta di anti-materia che nel mondo del Whisky chiamano “la parte degli angeli”.
Sarà stato anche per questo motivo che, dal 1984, essa cadde in disgrazia. Tacciata di forse di passatismo, dopo la ristrutturazione dell’istituzione del bar coincisa, in Sardegna, col 1984, essa subì la stessa sorte dei signori che la bevevano: venne ghettizzata, esclusa dalla coscienza contemporanea e celata alla vista poiché considerata inattuale a dispetto della sua imperitura natura.
Quanto a questa stessa natura, la Vernaccia di Oristano è un vino ossidativo ricchissimo di glicerina che la ammanta di una morbidezza particolarissima, e ne inspessisce la struttura consegnandola a un’esistenza senza età che già nel nome, unione del latino vernum (primavera, rinascita) con vernacula (luogo, carattere del luogo), parla del sempiterno, sacro legame ch’essa instaura con le coordinate dello spazio e del tempo.
Oltretutto, la sua natura non ascrivibile né al mondo del vino né a quello dei distillati le spalanca un mondo di abbinamenti apparentemente impossibili, come quello dell’amaro, del dolce e dell’amarissimo, si pensi al cioccolato nero, così come col mondo del salato con preciso riferimento alle conchiglie: ostriche, ricci di mare e bottarga in prima fila, mentre diventa una panacea se affiancata all’immateriale benché infestante universo del sigaro.

Ebbene, di questo mondo fantastico e irriducibile la Riserva 1968 è l’epitome: c’è più mordente, più concentrazione rispetto alle altre annate e, stranamente, la glicerina si è come smaterializzata consegnando al palato una sorso vitalissimo, teso, attraversato da un’energia quasi nervosa benché pacifica dove si avvicenda una rapinosa successione di salienze di cioccolato, fiori e sale, tantissimo sale, benché in una misteriosa, straziante, riposante freschezza ondivaga, continua e ricorsiva come la risacca del mare.
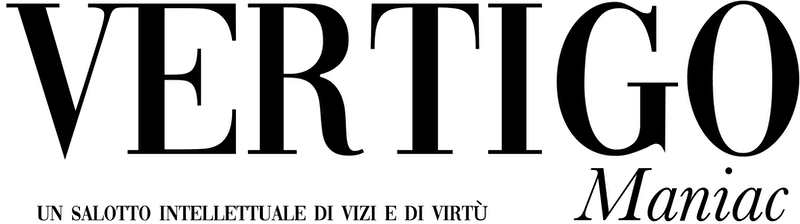








Commenti