Dove osano le aquile
Non c’era nessuna ragione per realizzare Top Gun: Maverick. Eppure, dopo averlo visto, lo reputo un film indispensabile.
Esagerazione? Forse. Nostalgia? Nel 1986 non ero nemmeno nato. Consapevolezza del momento storico? Centro.
A dirla chiara e tonda, Top Gun: Maverick ha senso solo se contestualizzato al momento che stiamo vivendo.
Che abbia senso non significa che non abbia legittimità. Se è legittimo realizzare un quinto capitolo di Indiana Jones senza Steven Spielberg in cabina di regia e con Harrison Ford sulla soglia degli 80 anni, come sta avvenendo in questi giorni, Top Gun: Maverick pare quasi doveroso.
Quasi, perché occorre guardarlo con un briciolo di obiettività. Obiettività nell’accettare, dalla prima inquadratura, col Top Gun Theme a cui segue Danger Zone, un film che ti spiattella in faccia il suo essere esattamente cosa ti aspetteresti se fossi tu, spettatore ingenuo seduto sulla poltroncina in sala, a realizzare un sequel di un film di cui sei innamorato, avendo a disposizione vagonate di milioni di dollari.

Cosa faresti se ti dessero questa possibilità? Esatto, dirigeresti un film in cui inserire le tue fantasie più immediate e appaganti per ricavarne il massimo godimento a ogni fotogramma. Lasciando fuori persone che, diciamocelo, non hanno la stessa sensibilità sul tema.
Top Gun: Maverick esce dopo due anni infernali, arrogandosi il diritto (e involontariamente l’onere) di reggere le sorti del prosieguo della ripresa del cinema – dalle prime proiezioni di incasso il film sta avendo ragione. Assurdo pensare che, in realtà, la pellicola fosse stata terminata prima della pandemia, dunque senza sovrastrutture messianiche di sorta. Ancor più assurdo se si considera il prodotto che si ha davanti.
Top Gun: Maverick ricalca il capostipite del 1986 in quasi tutte le sua parti. Cosa cambia? Nella forma, l’ammodernamento tecnologico; nella sostanza, nulla. Perché al centro c’è sempre lui, Tom Cruise.
Si poteva credere che in questo episodio ci sarebbe stato un “passaggio di consegne” verso una nuova generazione di piloti. Manco per morire. Il passaggio di consegne non c’è perché l’eroe è sempre lui, il buon vecchio Tom, che dall’alto dei suoi 59 anni si permette di rimettersi al comando di un progetto (e di un jet) imponendo una lezione alle nuove leve che solo un vecchio leone può dare.
Tom Cruise gestisce il secondo capitolo della saga nella stessa maniera in cui Sylvester Stallone aveva gestito quel capolavoro di Rocky Balboa (2006): il tempo incide su tutto e tutti ma se hai qualcosa da dire, se senti di avere i mezzi per tirare fuori la “bestia” e dimostrare al mondo che ancora ci sei, fallo.
Stallone aveva realizzato il sesto capitolo di Rocky come ultima chance per rilanciare una carriera praticamente finita. Cruise non ha la stessa incombenza. Eppure adotta lo stesso metodo.
Punta sulla spettacolarizzazione garantendo riconoscibilità e conferma delle aspettative. Non c’è un solo momento in cui si rischi qualcosa. Anzi, l’approccio classico viene esasperato e tirato a lucido da far spavento, con spontaneità e temerarietà spregiudicate.
E al buon Tom riesce il miracolo, com’era riuscito a Stallone.
Top Gun: Maverick trascende il ridicolo involontario e diventa qualcos’altro: diviene un film fuori dal tempo, una scheggia di cinema che, nella sua disarmante onestà, sfida retorica ed enfasi più plateali per riaffermare l’importanza di valori come coerenza, perseveranza e coraggio.
Il tutto al netto di un’immedesimazione tra Tom Cruise star e Tom Cruise attore imprescindibile dall’analisi.
Il rischio che la star prevalesse sull’attore era alto. Nonostante ciò, Cruise (attore), consapevole del pericolo, costruisce un Pete Mitchell che diventa allegoria di come Cruise (star) vede se stesso e l’intera industria cinematografica.
All’inizio del film un breve messaggio introduce la pellicola. Cruise in persona ringrazia gli spettatori per aver preso parte alla visione al cinema, non in streaming. Ringrazia noi e si carica sulle spalle il peso di una ripartenza del cinema stesso che, a fine 2019, non avremmo immaginato potesse palesarsi come in questi tristi anni. E lo fa puntando sulle basi, cioè sulla fiducia più profonda tra spettatore e film: intrattenere con onestà.
- Tom Cruise plays Capt. Pete “Maverick” Mitchell in Top Gun: Maverick from Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films.
Il suo Pete “Maverick” Mitchell è capace di insegnare a una generazione più giovane non tanto a compiere una manovra ma a perseverare nel mettere la componente umana al centro dell’azione, così come del cinema.
In fondo viene detto anche nel film, in uno scambio tra il protagonista ed Ed Harris: “La fine è inevitabile, Maverick. La tua razza è destinata all’estinzione.” “Forse, Signore. Ma non oggi.”
Per fortuna!
Ps: ha fatto molto scalpore l’assenza di Kelly McGillis. Non entro nel merito. Piuttosto mi soffermo sulla presenza di Val Kilmer. Il terreno era insidiosissimo: davvero malato di un tumore alla gola che ne ha compromesso per sempre la voce, Kilmer non si capiva bene come potesse entrare nel film e come sarebbe stato trattato l’indimenticabile “Iceman”. La soluzione trovata dagli sceneggiatori si è rivelata di una coerenza e un’umanità impensabili. Altro segnale della centralità del personaggio come essere umano con un senso e con dei valori, a prescindere dagli scettiscismi di sorta.
...segui Gianpietro.
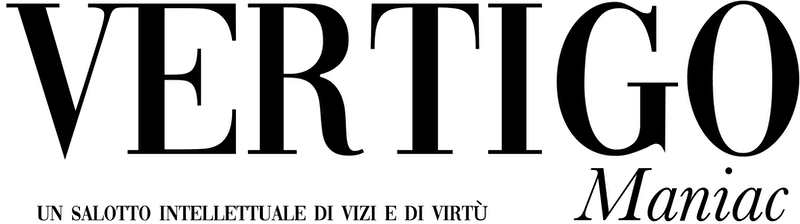




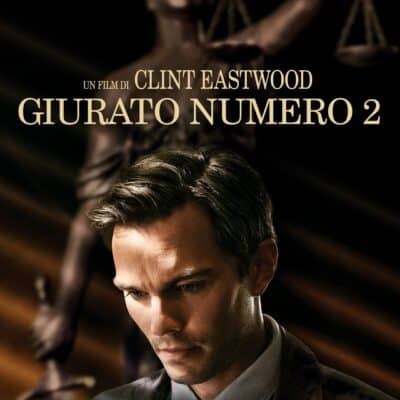




Commenti