Guerlain
Giuseppina Di Foggia
Milanese, laureato in Lettere e Filosofia (vecchio ordinamento), iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1993. Direttore editoriale della testata giornalistica online CityLightsNews ha insegnato Gastronomia sperimentale (Corso di Scienze e tecniche delle preparazioni alimentari) presso il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell’Università di Pavia. Collabora con la Guida I Ristoranti d’Italia de l’Espresso. Ha scritto numerosi libri su cibi e vini, anche da un punto di vista scientifico, tra cui, con Gualtiero Marchesi, l’Almanacco in cucina (Rizzoli) e, per ultimo, La Cucina Milanese (Hoepli).
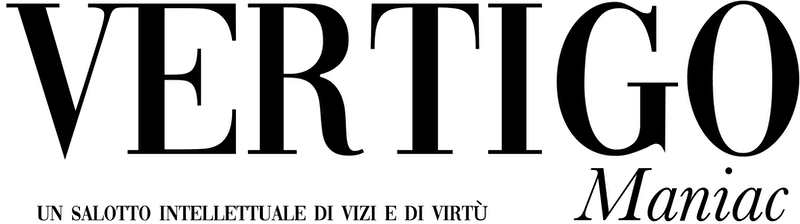











Commenti