Breve sogno di un uomo
Pindaro ce l’ha insegnato più di 2500 anni fa: sogno di un’ombra è l’uomo.
E dunque, come afferrare ciò che ne sta alla base, ciò che lo costituisce? Come comprendere cos’è l’uomo?
La domanda deve essere risuonata nella testa di Michele Placido e la risposta che si è dato potrebbe essere riassunta più o meno così: impossibile definire cosa sia l’uomo nel senso di “traguardo di un’indagine”; più accurato comprendere cosa sia l’uomo nel suo farsi, nel momento stesso in cui agisce, nel movimento in avanti verso un “oltre” che forse nemmeno lui conosce ma che lo identifica fosse solo per la vitale tensione che lo fa avanzare.
Materia densa e complessa l’opera di Caravaggio. Perché di Caravaggio è stato scritto tutto, è stato analizzato tutto, le sue opere sono patrimonio dell’umanità da secoli. Caravaggio è icona, simbolo, unisce le istanze più patriottiche con le aspirazioni più artistiche. Tanto elitario da tenere in coda migliaia di persone in un museo per poterne apprezzare un’opera quanto comune nell’essere finito per anni sulle mitologiche banconote da 100.000 lire; di tutti e di nessuno.
E quindi, chi era Caravaggio?
Per rispondere, Placido ci mette in guardia su quello che vediamo: non un uomo a tutto tondo ma la sua ombra, il suo riflesso, ciò che offre agli altri partendo da se stesso.
Poiché la questione per sua stessa natura è di difficile risoluzione, il regista pugliese sposa il punto di vista biografico, appoggiandosi a numerosi flashback per rievocare in più occasioni e più sfumature la genesi dell’opera caravaggesca. E qui si sostanzia la sorpresa, quella vera.
Perché L’Ombra di Caravaggio si disvela quale film davvero ben fatto, curato nella forma a tal punto da non sembrare nemmeno una produzione italiana (e in buona parte non lo è, considerata l’ingente partecipazione di capitali francesi) non solo nel modo di filmare le azioni del Merisi, ma nel senso che esse acquistano.
Di fronte a produzioni su personaggi così noti il rischio è la deriva da fiction in prima serata di Rai 1. Buoni sentimenti, finali accomodanti, politicamente corretto ad ammorbidire le sfumature meno gradite. Tutto edulcorato, nulla di veritiero.
Placido opta per l’esatto opposto: il film trasuda sporcizia, tentazione, peccato, sessualità, depravazione, stordimento, eccesso.
Non potendo mostrarci l’essenza dell’uomo-Caravaggio, Placido ci mostra la genesi delle sue opere filtrandola attraverso una corporeità che rende le immagini tattili. Pare di sentire l’odore dell’umanità malferma e malsana tanto amata dal Maestro. E dunque il rischio apologia viene evitato a piè pari in favore di una più sincera vicinanza a quella ricerca del “vero” tanto inseguita dal Merisi.
Il “vero”, dunque. Nella struttura diegetica “l’ombra” è l’inquisitore che deve indagare sulla condotta del pittore per legittimare o meno la grazia papale dopo l’omicidio Tommasoni. Nel profondo “l’ombra” è Caravaggio medesimo che fugge e rifugge da se stesso, incapace di pacificarsi e trovare un equilibrio in grado di salvarlo dai propri demoni.
I demoni, quegli stessi che lo abitavano e gli facevano cercare il sublime tra le prostitute più sciatte e consunte o tra gli ubriaconi più cenciosi e vergognosi. I demoni erano sempre presenti. Risuona nelle orecchie l’eudemonia greca, quella “felicità” data dalla capacità di convivere coi propri demoni buoni.
Nella magnifica sequenza della messa in opera de “La Morte della Vergine” si rasenta il sublime. I demoni buoni prevalgono e si coglie un senso di felicità che per un momento seda l’animo inquieto del Merisi. Ma presto i demoni cattivi, di per se stessi scalcianti al fine di definire per contrasto la presenza dei buoni, tornano alla ribalta e il gioco di auto-sabotaggio e redenzione riprende.
Nello sforzo complessivo, al netto degli ottimi risultati di messa in scena e fotografia, ne esce con le ossa rotte la sceneggiatura, incapace di lasciare alle immagini il compito di raccontare ciò che vediamo. Costantemente sul confine della spiegazione per neofiti, Placido teme che lo spettatore non abbia la sensibilità adatta per lasciarsi trasportare dell’inquietudine del suo (anti)eroe.
Aleksandr Sokurov, nel capolavoro troppo poco celebrato Faust (2011), aveva capito che il movimento vertiginoso del protagonista era la chiave di lettura per veicolarne il tormento. Placido pare guardare al regista russo, usa una macchina da presa mobile e febbricitante, si appoggia a un montaggio rapido e ipercinetico (a volte perdendo il focus della narrazione) ma infarcisce ogni sequenza di dialoghi pleonastici e riepiloghi didascalici. “L’ombra” si riduce a mero narratore indiretto indispensabile allo spettatore per non confondersi nella narrazione degli eventi.
La storia del Merisi è nota, bastano un paio di click per ricavare tutte le informazioni biografiche necessarie allo scopo; perdersi nel flusso delle immagini, facendosi forti solo dei propri sensi visivi, avrebbe avuto un senso diverso e, forse, più completo. Avrebbe forse permesso di entrare in contatto con l’animo del Caravaggio a un livello nuovo e inaspettato: il momento esatto in cui l’uomo concepisce l’opera e diventa artista.
Ma questa è un’ipotesi, un’ombra di ciò che avremmo potuto vedere.
Resta ciò che abbiamo di fronte: un quadro filmico, come quelli del maestro lombardo.
...segui Gianpietro.
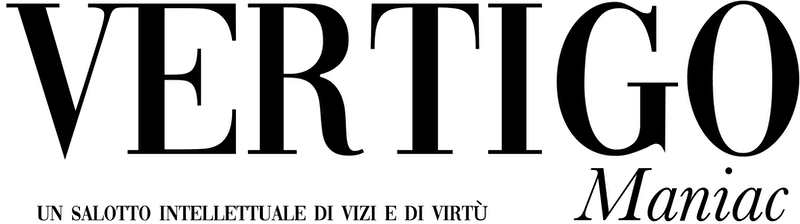






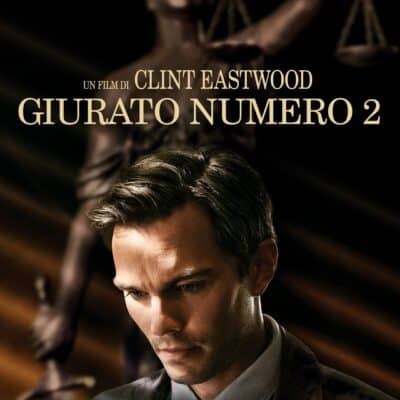




Commenti