La questione del legno e la lignificazione del bevitore contemporaneo
Quantunque l’essere umano, e tanto più colui il quale abbia a frequentare, per ragioni che non vogliamo indagare, il mondo del vino, sia costantemente irretito dalle tentazioni del narcisismo – e badate bene che sono proprio queste tentazioni che gli fanno istituire reti o, se preferite, relazioni rassicuranti, volte ad alimentare la naturale tendenza del narcisista alla conferma di sé stesso e, dunque, al pensiero unico – non c’è niente di più ammorbante, di più incartapecorente, di più necrotico del pensiero unico applicato al mondo vino.
C’è chi beve solo vini naturali perché quelli convenzionali sono tutti uguali e provocano mal di testa.
C’è chi quelli naturali non li può soffrire, invece, perché sono tutti uguali e perché poi, suvvia, puzzano.
C’è quello che beve solo rosso, perché col bianco ci si sciacqua la bocca… quello che le bollicine no, per favore, perché è vino quello?
C’è poi chi il legno non lo può soffrire, e quell’altro che non lo tollera solo nel vino bianco.
C’è poi quello che il rosato è un vino da femminucce e quell’altro ancora che beve solo vino locale, chiamiamolo campanilismo…
E, quindi, diciamolo subito: se al vino togli la sua molteplicità, se del vino fai un unico pensiero, un pensiero unico, non stai bevendo vino ma una proiezione di te stesso e lo stai strumentalizzando, questo vino, per una causa che ha te come unico – e spesso stolido – riferimento.
Si tratta, né più né meno, che di onanismo e, come l’onanismo, finisce per allontanare dal piacere, tanto più dal piacere del vino che per sua intima, squisita natura è controintuitivo perché è molteplicità e unità al contempo. Molteplicità di forme, potremmo dire, unità di contenuto.
L’unità del vino è una e unica: il vino buono che, vivaddio, si trova in una molteplicità di forme.
Questa unità è un fatto di ordine estetico – il vino buono – e come tale, appunto, deve essere preso: non si tratta di un “verbo” ma di un’aspirazione, una speranza, una tensione, una ricerca. Saper riconoscere un vino buono da un vino cattivo però non è solo un fatto assoluto e a priori, ma l’esito di un percorso di educazione, di cultura e di conoscenza.
Prendi il legno: la questione del legno per il sedicente enofilo può essere paradigmatica perché si tratta di una questione evolutiva.
C’è sempre una fase superata quella, iniziale, dell’entusiasmo circa vini palesemente “barriccati” in cui il legno diventa, per il bevitore che comincia a considerarsi edotto in materia, un vaso di Pandora e, come tale, foriero di tutti i mali del mondo; un’opinione, questa, comprovata a fortiori dalla evidenza delle ancora tante “spremute di legno” presenti, in effetti, sul mercato.
Eppure, assolutizzare questa evidenza finisce per essere un abito altrettanto insidioso a meno, certo, che strumentalizzare il vino non sia effettivamente parte dei vostri propositi: ecco, in tal caso sappiate che non avete bisogno di un buon vino ma di un bravo psicoterapeuta o, tuttalpiù, di uno specchio fatato o di un buon filtro su Instagram.
Tornando, dunque, al legno, esso è, com’è noto, l’amico più intimo dei più grandi terroir del mondo del vino (uno su tutti la Borgogna); come mai, dunque, proprio il legno ha determinato, altrove, un tale fraintendimento?
A questo proposito, pagine molto illuminanti sono state vergate da Jacky Rigaux – che non a caso è psicologo, nato in Borgogna dov’è responsabile della formazione enologica presso l’Università di Digione – e raccolte dal “nostro” Sandro Sangiorgi in un illuminato, accurato, accorato volume, edito da Porthos Edizioni di nome “Il Vino Capovolto“:
“Henri Jayer lamentava che alcuni vignaioli, eccellenti viticoltori e vinificatori, trascurassero l’allevamento dei vini in cantina. Negli anni sessanta e settanta, si era spesso abbandonato l’uso della maturazione in botte a favore della vasca di acciaio, più facile da usare, anche per i grandi terroir. Come sosteneva Jayer, fedele agli insegnamenti della viticoltura del XVIII e del XIX secolo, il tempo dell’allevamento in vigna è importante quanto il tempo della vinificazione. La maturazione deve avvenire in botti di rovere provenienti dalle migliori foreste, garanzia di legno a grana fine. Quando la qualità del terroir lo consente, la botte di legno nuovo è sempre preferibile alla botte usata uno, due o tre volte.”
p.64
E ancora:
“La maturazione in botte fa sì che il tessuto naturale del vino possa svilupparsi, affinarsi nel rispetto delle identità di ogni terroir.”
p.66
Lo diceva Henri Jayer, artefice di vini dall’impareggiabile tessitura gusto-olfattiva: un linguaggio, una semantica subliminale che conduceva il degustatore nient’altri che presso il terroir donde questi provenivano: Echezeaux, Richebourg, Cros Parantoux…
Non è quindi il legno il colpevole, ma l’assenza del terroir la quale coincide, o dovrebbe coincidere, per dirla elegantemente, con l’assenza del vino stesso.
Un esempio italico per ciò che concerne l’uso del legno – esemplare, in barrique (nuove per un terzo) dove si svolge sia la fermentazione che la malolattica – arriva dall’Abbazia di Novacella che coi 650 metri sul livello del mare ci consegna quello che potrebbe essere secondo molti il Pinot bianco più settentrionale d’Italia.
E si tratta di un vino vivo: un vino che si spoglia generoso e languido, a poco a poco, delle sue note alsaziane di burro fuso e geosmina per librarsi in un volo di fiori tardo-primaverili, di tiglio e polpe e balsami d’agrumi anche al palato dove un’acidità viperina ma deliziosa incalza e si combina, in un quadro sfaccettato ma arioso di acuti, con una materia voluminosa e consistente.

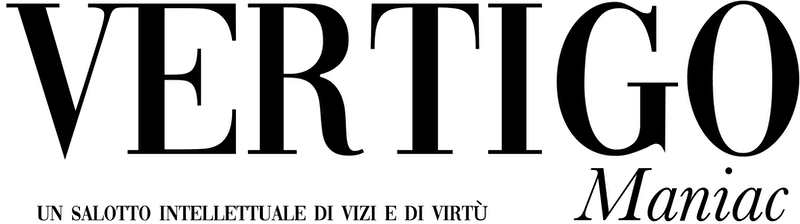



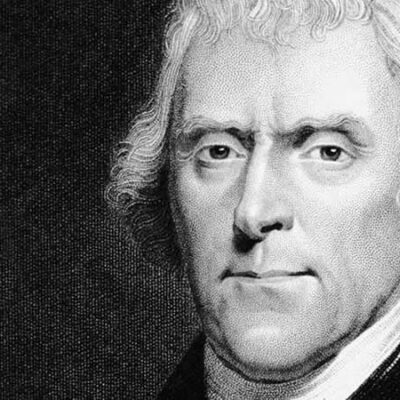




Commenti