Ludovico
Quando si era risvegliato in ospedale e gli avevano detto che non avrebbe più camminato, Ludovico Stianigo non disse nulla. Ascoltò in silenzio, guardando fisso davanti a sé.
La camera dell’ospedale esisteva ma era come se non fosse davvero lì. Le pareti bianche, ebbre di odore di candeggina e disinfettante, potevano sfumare e a Ludovico non sarebbe cambiato nulla. Ludovico non sarebbe cambiato.
I medici gli dissero che la caduta aveva lesionato il midollo spinale in maniera irreversibile. Gli parlarono con calma e gentilezza, non dimenticando però di aggiungere che non c’era nulla che avrebbero potuto fare per cambiare la situazione.
Un’ora dopo che i medici avevano lasciato la stanza, in attesa che arrivasse il fratello Steno, Ludovico guardò ancora le pareti e scoppiò a piangere. Fu un pianto sommesso ma disperato. Non era solo la condizione di invalido a rendergli dolorosa la realtà ma la consapevolezza che la responsabilità era sua. Aveva accettato lui di andare da Fabiano Quattromozzi di domenica, suo compaesano in quel di Albaredo d’Adige, per sistemargli il pannello fotovoltaico, a fronte di un compenso di 150,00€ in nero e di una bottiglia di Amarone presa al supermercato. Di nero ne faceva molto, Ludovico. E non gli bastava. Doveva lavorare tredici ore al giorno, sei giorni su sette, versando i contributi per una RAL di poco superiore ai 15.000,00 € dichiarati, quando invece ne prendeva almeno il doppio. I soldi non bastavano mai ma era la smania d’agire, d’essere attivo e operativo, a muoverlo. Aveva solo il lavoro. Le relazioni sentimentali non gli erano mai interessate, se non per qualche fugace incontro fisico con la sventurata di turno, a pagamento. Il lavoro era l’unico strumento tramite il quale poteva definire se stesso nel paese. Non a caso lo avevano soprannominato “il principe”, a seguito del cambio di auto semestrale che si concedeva da dieci anni a quella parte, sfrecciando per le vie di campagna di Albaredo e frazioni, soprattutto Presina. Non gli era dunque parso un problema lavorare di domenica. Ma il sabato precedente alla maledetta domenica, la nebbia, che sempre abbracciava le campagne della bassa veronese in autunno, aveva avvolto Albaredo sotto a una coltre bassa e grigia che l’indomani aveva lasciato strati spessi di umidità su ogni superficie. Ludovico, nel preparare il furgone, salito sul tetto del Peugeot Partner comprato un anno prima, mentre sistemava la scala, era scivolato a causa della superficie bagnata e delle scarpe inzaccherate. La caduta era stata rovinosa e gli aveva fratturato le vertebre T10 e T11. Il dolore era stato talmente acuto da provocargli uno shock che lo aveva fatto svenire. La domenica mattina, sebbene fosse fine novembre, c’era il sole. I medici gli dissero che Fabiano aveva chiamato un’ambulanza non avendolo visto arrivare, dopo essere andato a casa sua, non essendo riuscito a rintracciarlo al telefono. Tutto si poteva dire di Ludovico Stianigo ma non che non fosse uno stacanovista. Questo era certo. Ora di certo si poteva aggiungere un’altra cosa: non avrebbe più camminato.
Il mercoledì dopo l’incidente, mentre di nuovo piangeva nella stanza dell’ospedale consapevole di essere divenuto un paraplegico (o meglio: un handicappato, come avrebbero detto successivamente in paese), Ludovico si calmò solo quando una risata ne bloccò le lacrime. Ludovico rise per la prima volta dal risveglio pensando che ora non era più solo “il principe di Albaredo”; ora era divenuto “il principe degli handicappati di Albaredo”.
Suo fratello Steno, l’unico parente che gli era rimasto, gli stette vicino nei mesi che seguirono. Steno lo aiutò a riorganizzare la casa con scivoli e montascale. La carrozzina fu la prima cosa che gli portò, quando lo andò a visitare in ospedale. Ludovico vi prese dimestichezza rapidamente. La riabilitazione post-degenza era durata meno del previsto. Spinto dal risentimento per quanto gli era avvenuto, Ludovico aveva imparato a destreggiarsi sul mezzo con sorprendente abilità. Gli anni di lavoro sui tetti, spesso in condizioni meteo avverse, lo avevano rinforzato negli avambracci più di quanto immaginasse. Ironico, aveva pensato Ludovico, contando che per anni era andato in palestra a rinforzare le gambe, quelle stesse gambe che ora non sentiva più e con le quali aveva nutrito l’unica passione che aveva, il windsurf. Steno si era occupato delle scartoffie e aveva ottenuto con rapidità la pensione di invalidità. L’azione fu svolta con solerzia per due ragioni: aiutare il fratello senza che ad Albaredo si vociferasse che, nel momento del bisogno, Ludovico era rimasto da solo; rendere quanto prima autonomo Ludovico stesso, così da permettere a Steno di stare con la propria famiglia, liberandolo del peso di compiere il tragitto che separava Albaredo da Fumane, dove Steno viveva con moglie e due figli adolescenti. Avere un fratello col quale non andare d’accordo era un conto; avere un fratello disabile col quale non andare d’accordo era un’altra cosa. Steno doveva dimostrare di essere superiore a Ludovico e alla sua smania di soldi che tanto lo avevano fatto incazzare per la spartizione dei beni dei genitori. Ora ne aveva l’occasione. Sistemato l’iter burocratico per la nuova autonomia di Ludovico, Steno era convinto che i soldi messi da parte dal fratello, quelli non dichiarati, sarebbero stati utili per garantire un briciolo di dignità alla vita di Ludovico. Per una volta l’avarizia di Ludovico, utile fino all’incidente solo ad alimentare la solitudine relazionale che lo circondava, aveva un riflesso positivo per le persone allontanate. O così credeva Steno, poiché dei soldi di cui conosceva l’esistenza considerata l’attività del fratello, ma non l’ubicazione, Ludovico non aveva mai parlato apertamente.
Nella nuova realtà da paraplegico, Ludovico si era ritrovato a desiderare l’oblio. Beveva più del dovuto, si faceva portare la spesa a casa tramite il delivery e trascorreva le proprie giornate, quando non presente Steno, a guardare video di windsurf o surf, maledicendo il mondo per averlo ridotto su una sedia a rotelle. Le poche volte in cui era stato invitato a casa di Steno, non essendo ancora munito di auto dedicata, e non volendosene munire, già solo presentarsi davanti ai nipoti e alla moglie del fratello, coi quali manteneva un legame di formale disinteresse, era stato per Ludovico un supplizio di indesiderata pietà che lo aveva fatto imbestialire. Nulla era peggiore che sentirsi compatiti quando rimpiangevi la normalità perduta. Riconfermava il tuo immobilismo, fisico e personale. Ludovico se ne era reso conto alla svelta, a cominciare dai parenti, per proseguire coi compaesani i quali, vedendolo, scuotevano la testa in segno di rammarico, bofonchiando parole che Ludovico non udiva ma di cui immaginava il contenuto.
Guarda cosa gli è successo. Povero Ludovico. Povero handicappato.
Steno, al netto delle sbronze colossali che si era preso il fratello nei pochi momenti conviviali successivi all’incidente, incontri conclusi con bestemmie creative rivolte contro tutta l’umanità, parenti compresi, aveva presto deciso di limitare allo stretto necessario le visite a Ludovico. Erano sufficienti le feste comandate. Per il resto, gli bastava chiamare il fratello un paio di volte a settimana, sostenendo conversazioni di circostanza della durata di pochi minuti nelle quali il semplice sapere che Ludovico non era morto era utile a segnare come “eseguito” il dovere relazionale che lo legava a causa dei vincoli di sangue che non aveva richiesto ma che comunque aveva ereditato.
E la questione dell’eredità diventò presto un pensiero fisso per Steno: Ludovico era ricco, molto ricco, molto più di quanto non lo avesse informato dopo l’incidente, per quel nulla di cui lo aveva informato. E quando fosse morto, a chi sarebbero andati i soldi non dichiarati? Questione annosa, che teneva Steno sull’attenti affinché la propria distanza dal fratello non si rivelasse davvero per ciò che era: disgusto.
Passarono quattro mesi. I ragionamenti di Steno, rinforzati dalla moglie Giovanna, divennero sempre più pressanti tanto da portarlo a trovare una soluzione che gli permettesse di ingraziarsi il fratello senza stargli fisicamente appresso.
L’idea gli venne guardando una puntata di Geo, ambientata in Emilia-Romagna. Il protagonista, un apicoltore hippie che viveva in un casolare lontano dalla modernità, aveva la sola compagnia di un cane, un pastore maremmano. Fu una folgorazione: Steno avrebbe regalato a Ludovico un cane.
Poiché i costi di un cane di razza erano proibitivi, Steno riuscì a farsi regalare da un amico agricoltore un cucciolo bastardo figlio della Labrador che aveva partorito pochi mesi prima e di cui l’amico agricoltore era proprietario da cinque anni. La madre del cucciolo era di razza; il padre, invece, era a sua volta un bastardo, un incrocio tra un pastore tedesco e una Golden Retriever. Per Steno era utile che il cane fosse di taglia medio-grande, così da infondere un senso di compagnia con la sola presenza. Il pedigree era secondario.
Quando Steno, verso la fine della primavera successiva all’incidente, aveva portato il cucciolo al fratello, dicendogli che aveva una sorpresa, non sapeva che nome dare all’animale. Pensò e ripensò a un nome comune, ma tutti i nomi che conosceva gli parevano troppo comuni. In suo soccorso arrivò la nenia che aveva ascoltato da parte della figlia, in seconda media, il giorno prima della consegna dell’animale. La ragazza, Maddalena, stava ripetendo a pappagallo l’incipit del primo canto dell’Inferno per un’interrogazione di recupero. Steno capì come chiamare il cucciolo: Dante.
Ludovico ascoltò le parole del fratello senza ribattere. Steno gli presentò Dante sottolineandone la bellezza dello splendido mantello fulvo e aggiungendo che il cane era di “razza” buona, proveniva cioè da una famiglia di cani fedeli e collaborativi che non creavano problemi e che imparavano alla svelta, condizione indispensabile per l’autonomia che l’animale avrebbe dovuto acquisire in tempi celeri, soprattutto quando avrebbe dovuto fare i propri bisogni. Il sangue non è acqua, concluse Steno per avvalorare il proprio gesto. Ludovico non mosse alcuna obiezione, si limitò a osservare il fratello e a squadrare il cane. Quando Steno se ne andò, lasciando i due a casa da soli per la prima volta, Ludovico osservò il cucciolo aggirarsi scodinzolando per la cucina, annusando ogni pertugio. Quando Dante si avvicinò al nuovo padrone e si eresse sulle zampette posteriori, appoggiandosi alla ruota della sedia a rotelle, Ludovico lo fissò. Si guardarono per qualche secondo ma il tempo sembrò fermarsi. Dante era attratto da quell’uomo che lo osservava senza dire una parola; Ludovico coglieva negli occhi del cucciolo un affetto sul punto di esplodere.
L’uomo fece scattare la mano sinistra senza che Dante potesse prevederlo. Il colpo fu dato con una tale fermezza, forte anche dei muscoli dell’avambraccio, che scaraventò l’animale contro la sedia della cucina, facendolo scoppiare in acuti guaiti.
Ludovico osservò il cane per qualche istante, finché questi non smise di lamentarsi. Dante si rialzò e tornò a fissarlo. Questa volta, però, il cane rimase immobile. Dante fissava il padrone con occhio fermo e colmo d’odio. Non ringhiò. Si limitò a girarsi e a trovarsi un angolo dove rannicchiarsi, lontano dall’uomo.
Ludovico si mosse solo dopo che Dante gli fu a cinque metri di distanza.
Era felice di non aver ceduto all’affetto che gli aveva suggerito il cane, ma al contempo provava una sensazione che non avrebbe saputo definire con altri termini se non con uno: inquietudine.
(clicca QUI per leggere l’episodio precedente)
...segui Gianpietro.
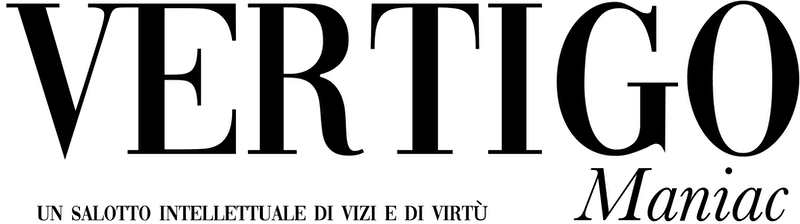







Commenti