Barbara Schiavulli: reporter in rosa
Valigia rosa, stilografica rosa e giubbotto antiproiettile con la scritta PRESS in rosa. A tredici anni aveva già il sacro fuoco del giornalismo, anzi, voleva fare proprio l’inviata di guerra. Inizi in cronaca al Gazzettino di Venezia, poi in giro per il mondo a caccia di storie, tra conflitti e tragedie. Dopo qualche decennio, Barbara Schiavulli ha conservato l’entusiasmo della principiante, ma condito dalla delusione per i media italiani.
Radio bullets (radiobullets.com), la testata giornalistica online che ha fondato, è diventata la sua rivincita.
“Credevo che se fossi stata abbastanza brava mi si sarebbero spalancate le porte dei giornali, ma così non è stato”: a tuo parere, per quale motivo?
«Il nostro è un Paese difficile dal punto di vista giornalistico. Volevo fare un lavoro molto più anglosassone, raccontando i fatti e le storie. In Italia, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, il giornalismo è fazioso, se a fronte del lavoro fatto in modo competente e professionale uno non ha speranza vuol dire che c’è un problema. Quando ho cominciato, alla fine degli anni ’90, si veniva assunti soprattutto per raccomandazione. Ho scritto per tutti i giornali principali, perché comunque portavo cose dalle in zone di guerra che magari altri non avevano. Sono andata vicino all’assunzione con l’Espresso, dove mi avevano fatto un contratto a termine, poi è arrivata la crisi del 2008 e non se ne è più parlato. Trecentomila follower e un paio di selfie contano molto di più di esperienza e competenza: questo per il giornalismo italiano è deleterio, ma ancor di più per la società civile che non riesce a essere informata come meriterebbe».
Come hai elaborato questo “rifiuto”?
«Trasformo la rabbia in progetti costruttivi: l’arrivo dei talebani in Afghanistan è diventato un libro, l’irritazione verso il giornalismo italiano ha preso la forma di una piccola testata (RADIOBULLETS.COM) che funziona come penso dovrebbero funzionare quei posti dove si fa informazione. Se lo faccio senza soldi e la gente mi segue e mi dice che sto facendo un lavoro magnifico, pensa cosa potrei fare se avessi i soldi».
In compenso hai vinto tanti premi…
«Mi sono sfogata tante volte dicendo che avrei mollato, in realtà non sono capace di fare altro. C’è uno scollamento tra giornalismo mainstream e lettori che ti sostengono, ti dicono di tenere duro e vengono ad ascoltarti alle conferenze. Dico alle persone che per andare due settimane in un posto ho bisogno di tot soldi e trovo gente sconosciuta capace di donare dai cinque ai mille euro: oggi il mio datore di lavoro sono i lettori».
Hai mai sentito di aver fatto la differenza e che il tuo impegno era servito a qualcosa?
«Questo lavoro è un privilegio perché ci permette di entrare nelle case delle persone e di ascoltare il loro dolore. Prima facevo quello che chiedevano i giornali, adesso quello che penso sia necessario per la gente, una sorta di giornalismo più umanitario: a me piace raccontare le storie dei civili che subiscono la guerra e in alcune occasioni, grazie alle ONG, e a volte a colpi di fortuna, sono riuscita anche ad aiutare qualcuno in difficoltà. La cosa più importante è riuscire a trasformare la scrittura in un mezzo per fare la differenza».
Come affronti la necessità di essere super partes, di non partire con un’idea e cercare conferme a quella?
«So di avere dei preconcetti, ma forse anche questo si impara con l’esperienza. Sono una che si immedesima molto: il complimento più bello che mi hanno fatto le donne afghane quando ho scritto l’ultimo libro è stato che non scrivo come un’occidentale, ma come una di loro. Vuol dire che in qualche modo i preconcetti li puoi anche demolire. Cerco di andare il più aperta possibile e di lasciarmi travolgere, ma sempre dalla parte della gente. Però ci sono i fatti che ci possono supportare: i numeri, i dati aiutano a raccontare, a fronte della faziosità che spesso ci circonda. Non avere preconcetti è quasi impossibile, ma è importante mettersi ad ascoltare le persone, le opinioni, cosa provano mentre stanno vivendo le cose. Anche l’istinto è importante, sembra un po’ una cosa magica, ma in realtà a volte bisogna fidarsi: in tante occasioni ha fatto la differenza».
Prima volta all’estero per un reportage?
«Nel ’97. Avevo degli amici palestinesi e sono scesa a intervistare Arafat: dovevo stare una settimana e sono rimasta quattro anni».
Come hai imparato a fare l’inviato di guerra?
«Come si faceva una volta, sono stata la coda di quel giornalismo di inviati alla Ettore Mo o Robert Fisk. All’inizio seguivo i fotografi più che i giornalisti, perché sono sempre in prima linea. Alla fine degli anni Novanta nei luoghi caldi trovavi tutti i grandi inviati. Israele-Palestina era il conflitto per eccellenza potevi essere su un fronte e sull’altro contemporaneamente: vedevi da una parte i soprusi e le oppressione di Israele, dall’altra il kamikaze che si faceva esplodere nel ristorante dove la sera prima avevi mangiato.
Dovevi cercare di capire, districarti nella complessità perché non c’è niente di semplice, non ci sono mai buoni e cattivi in guerra.
Una volta, durante l’assedio di Ramallah, sono uscita con Robert Fisk dall’ufficio dove stava Arafat: mi diceva di stargli vicino perché così mi poteva coprire col suo giubbotto antiproiettile, che io ancora non mi potevo permettere. Abbiamo fatto chilometri a piedi ed ero con Robert Fisk, un monumento del giornalismo: assorbivo e piano piano mi formavo. Poi quando hai le basi cominci a fare la tua strada: fino al 2008 è stato bello, si facevano grandi reportage a tutta pagina».
Quella stagione è sostanzialmente finita: cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio?
«Era un giornalismo migliore dal punto di vista dei reporter, ma meno controllabile. Ci si basava sull’onestà degli inviati e non tutti lo sono stati, nessuno poteva verificare niente. Oggi puoi controllare tutto, c’è ancora qualcuno che magari non esce dall’albergo o costruisce un’intervista esclusiva da una conferenza stampa, però sono una minoranza. Hai maggior facilità a mandare i pezzi, tecnologicamente il lavoro si è velocizzato, anche se questo non è necessariamente un pregio, però hai accesso a una quantità di materiale enorme, se uno volesse veramente fare le cose bene potrebbe farlo. Si può parlare con paesi chiusi come l’Iran anche senza essere sul posto, con tutte le difficoltà del caso perché sappiamo bene che la guerra significa anche propaganda e bugie… Quello che manca è il sedimentare della storia.
Ettore Mo spariva per settimane, nessuno sapeva dove fosse, poi tornava e ti scriveva quattro pagine memorabili.
Adesso rientri in albergo e in un quarto d’ora devi mandare la notizia, fare video e post».
Viaggi, spese, assicurazione e tutto il resto li paghi con i finanziamenti di Radio bullets?
«Al momento sì, prima, fino circa al 2012, scrivevo per tanti giornali e mi ripagavo le spese. Stando all’estero dieci mesi l’anno era una ruota che girava: quando mi arrivavano i soldi già stavo lavorando su altre cose. Adesso ci sono anche bandi, finanziamenti e il crowdfunding. A Radio bullets se riusciamo ad avere duemila persone che mettono quattro euro al mese possiamo campare. Dare i miei pezzi a giornali di cui non condivido la linea per me è diventata prostituzione di parole».
Quanto ti pagavano un reportage da una zona di guerra?
«L’Espresso mi dava 2.000 euro, Avvenire 150, ma parliamo dei tempi della guerra in Iraq. Adesso LA REPUBBLICA, per la quale non voglio scrivere più, me ne darebbe 250. Solo il traduttore mi costa 150…»
Una volta che hai avuto veramente paura?
«Un sacco di volte! Le persone che fanno questo mestiere sicuramente hanno un livello di convivenza con la paura diverso dalla media, devi essere in qualche modo preparato, non uno che panica. La mia grande preoccupazione è sempre per il fixer (persona del luogo che aiuta gli inviati a muoversi sul campo, ndr.) e per quelli che lavorano con me, se succedesse qualcosa a loro mi sconvolgerebbe davvero. Un collega diceva: “Se non torni in albergo a scrivere la storia vuol dire che hai fallito” e questa è una linea che ho seguito sempre. In Iraq c’è stato un momento in cui c’erano dieci attentati al giorno e cercavano gli stranieri; io ho il vantaggio fisico di sembrare una del posto e questo me lo sono usato tante volte».
Quante rinunce è costata la vita che hai scelto?
«Direi nessuna perché era quello che volevo fare. Certo, la vita sentimentale non è facile, spesso mi è stato detto che non si potevano affezionare “perché poi se sei in pericolo io ho paura”, ma se prendi me prendi tutto il pacchetto. Non ho rimpianti, mi sento libera, ho vissuto avventure da film e non sento la necessità di tornare a casa e trovare qualcuno a cui fare il resoconto. I figli non li ho mai voluti e oggi, col mondo che c’è, sarei terrorizzata dal futuro».
Ryszard Kapuścinski, grande inviato, diceva che il cinico non è adatto a questo mestiere: quanto ti pesa emotivamente filtrare quello che vedi durante il giorno?
«All’inizio molto di più perché era tutto nuovo, emozioni che non avevo mai sperimentato. Col tempo ti fai quella corazza necessaria, ma concordo che non deve essere una torre. Nel 2003, due settimane dopo il ritorno dall’Iran dove c’era stato il terremoto, continuavo a sentire la puzza di cadavere addosso. Forse per le donne è più facile: siamo più complesse e riusciamo a elaborare meglio degli uomini. La scrittura mi ha sempre aiutato moltissimo. Quando ero giovane tornavo e per tre giorni andavo tutte le sere a ballare la salsa e mi ammazzavo di stanchezza; adesso non ne ho più bisogno, però ancora oggi quando vedo in Afghanistan mamme costrette a vendere i bambini perché non hanno i soldi per sfamare gli altri o una donna stuprata che ti racconta della sorella a cui hanno tagliato la pancia e tirato fuori il bambino sfido chiunque a restare impassibile».
Un altro grande, Tiziano Terzani, diceva che la prima volta che vedi un morto resti scioccato, poi cominci a contarli perché è il tuo mestiere…
«Il punto è che devi usare quell’emozione, quel morto per fare un buon giornalismo, trasformare la vita di quella persona in una storia che merita di essere raccontata: devi trasmettere la pelle d’oca provata in quel luogo».
Esiste un tuo modello giornalistico?
«Mi piace moltissimo come scriveva Marta Gellhorn; oppure la Fallaci, anche se non condivido la parte finale del suo percorso».
Un consiglio a un giovane aspirante giornalista di guerra?
«Fare l’idraulico».
Cos’è per te il senso del dovere?
«Il mio senso del dovere e anche un difetto perché sono incapace di mollare. Se devo fare una cosa la faccio venisse giù il mondo, non riesco a rompere un impegno per la lealtà verso le persone. Poi, garantire che le cose che scrivo siano almeno intellettualmente oneste. La propaganda a volte è talmente forte che ti può anche fregare: se è successo l’ho fatto in buona fede».
Rimpianti?
«Beh, mi sarebbe piaciuto essere assunta solo per il fatto di essere assunta. E capisco che sia una stupidata, perché magari sarei stata infelice come sono infelici molti assunti. Però l’idea che qualcuno dicesse ti prendiamo come inviata, lavori per noi, ti paghiamo e copriamo le spese sarebbe stato un bel traguardo. Un’altra cosa che avrei forse dovuto fare dopo aver abitato in Israele è non tornare in Italia: probabilmente in un altro posto a quest’ora un giornale lo dirigerei. È presuntuoso quello che dico, ma non fai questo mestiere senza un po’ di presunzione. Non l’ho fatto perché pensavo che la cosa più importante fosse parlare alla mia di gente…»
Sei ottimista sul futuro del giornalismo italiano?
«Finché la qualità non diventerà il filtro, saremo sempre alla mercé del peggio. Mi spaventa una società che non capisce che i diritti non sono per sempre, che vede gli altri come invasori e che lascia morire la gente in mare senza nessun tipo di empatia. Non sono ottimista».
...segui Barbara Schiavulli.
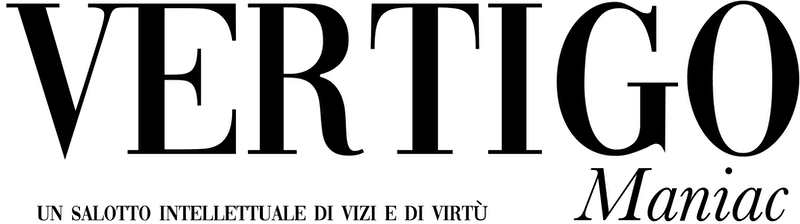





















Commenti