Cercasi Sean disperatamente
Sean Penn ha un dono: la marginalità.
Due premi Oscar come miglior attore, cinque candidature complessive, un paio di matrimoni burrascosi, di cui uno con Madonna, rapporti conflittuali con la stampa, carattere improbabile, Sean Penn è l’archetipo dell’anti-star, un attore pienamente addentro allo star system ma al contempo ai suoi margini. Parlo di una marginalità volontaria, non imposta.
A ben guardarne la filmografia, pochi sono i casi in cui una sua pellicola è stata un blockbuster. Nella quasi totalità, Penn ha scelto la strada della messa in discussione, dei film a budget medio-alto, spesso medio-basso, puntando su storie che avessero qualcosa da dire al di là del semplice film in quanto tale – basti pensare ai film per i quali ha vinto l’Oscar o per i quali è stato candidato.
Per non parlare della vita privata extra-professionale e relazionale, connaturata da attivismo, incontri con narcotrafficanti internazionali e simpatie non troppo velate per regimi filo-comunisti diametralmente opposti al “sogno americano” di cui, per assurdo, Penn stesso ne incarna una parte.
Se nei film in cui compare come attore l’equilibrio tra status di star e volontà auto-esiliante è ben gestita, nei film in cui Penn ricopre il ruolo di regista l’ago della bilancia pende verso la seconda predisposizione.
Il tanto, e giustamente, celebrato Into the Wild (2007) è lì a dircelo chiaramente: la vita di un ragazzo che, in maniera consapevole, va incontro alla morte, da solo, allontanandosi da tutti e decidendo di isolarsi per raggiungere uno zenit esistenziale impossibile da ottenere nella società.
Una vita in fuga, uscito quest’anno, brutta traduzione di Flag Day, ultimo film di Penn regista, è anche il primo caso in cui l’attore recita. La pellicola rielabora le istanze Into the Wild: raccontare la marginalità, appoggiandosi a un impianto apparentemente classico ma dagli elementi interni non certo standard.
Se da una parte la vicenda di questo “padre Peter Pan” incapace di gestire le responsabilità genitoriali rientra perfettamente nelle coordinate di cui ho accennato, da un’altra Penn spinge l’acceleratore sulla biografia, chiamando i propri figli a recitare le parti dei figli del protagonista.
La simbiosi è totale e, purtroppo, il film non ne esce indenne.
Gli aspetti positivi sono molti, a cominciare dai duetti di Penn con la figlia Dylan. La giovane tiene testa al padre con una grazia insospettabile, pari solo all’immedesimazione che Penn mette nell’impersonare questo anti-eroe spinto da sincere e approssimative spinte emotive, e velleità malavitose troppo grandi per lui.
Alle parti recitate si uniscono le scelte stilistiche: come in Into the Wild, Penn punta al lirismo, lavora per sovrapposizioni di immagini di vari formati e varie grane per rendere il lato più soggettivo e personale della relazione tra i protagonisti, giocando con la memoria e la sua soggettività.
Se non bastasse, Penn ha anche la rara capacità di costruire immagini capaci, con semplici dettagli, di rendere la solitudine dei protagonisti in maniera diretta e immediata.
Una scena mi ha particolarmente colpito: la protagonista, nel suo pellegrinaggio, si imbatte in un temporale. Per sfuggire alle intemperie, si ripara sotto un cavalcavia, vicina a un clochard appisolato su una panchina. Sprovvista di ripari, la giovane ruba un telo di plastica al senzatetto e se ne va, sotto lo sguardo malinconico di quest’ultimo.
La sequenza è di raccordo e dura pochi minuti. Eppure, nella sua brevità, rende al meglio il carattere del personaggio e del mondo in cui è inserito, senza particolari enfasi ma non con puntuale precisione.
Eppure, al netto delle premesse, Penn sbaglia la costruzione generale, focalizzandosi sulla riuscita di sequenze singole al netto dell’insieme.
Impossibile non storcere il naso di fronte alla scene nelle quali lui e la figlia non recitano assieme. La brutta sezione del primo atto con in scena il patrigno molestatore grida vendetta. I personaggi sono stereotipati e laidi, le recitazioni vanno spesso in overacting e la macchina da presa, a mano, non capisce bene chi inquadrare né quando, arrivando spesso a riprendere involontariamente gli attori fuori fuoco.
Lo stesso vale per la voce fuori campo e la colonna sonora.
Suggestionato dal cinema di Terrence Malick, con cui ha collaborato due volte, Penn sovraccarica Una vita in fuga di canzoni strappalacrime (non se ne può più delle lagne acustiche e lacrimevoli di Eddie Vedder) e sottolineature voice over scontate ed enfatiche. Malick usa questi elementi per raggiungere il sublime, per creare poemi filmati; Penn per ingraziarsi l’enfasi dello spettatore.
Se la formula aveva una propria legittimità in Into the Wild, in un film come Una vita in fuga, dall’intreccio più prettamente narrativo, stona.
Non perché Penn non sia abile a gestire questi strumenti ma perché è ancora più abile a comunicare ciò che vuole dire con le immagini, dunque, sovraccaricandole, ne compromette la riuscita complessiva, scivolando nella ridondanza.
E la ridondanza porta a un risultato: l’indigestione.
Peccato.
...segui Gianpietro.
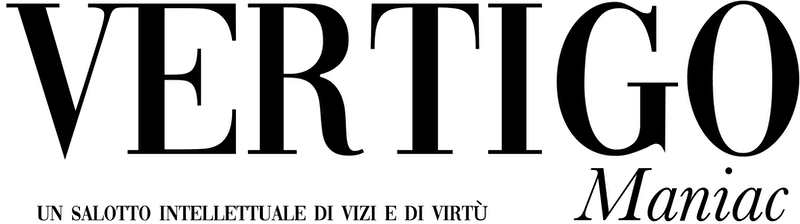





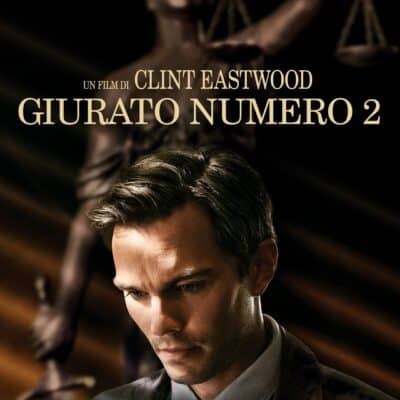




Commenti