I sudari del film saggio
82 anni e lo status di autore di culto. A ragione.
Cosa potrebbe stimolare ancora l’inventiva di chi si trova in questa posizione? Difficile dirlo, soprattutto se ti chiami David Cronenberg.
Negli ultimi dieci anni DAVID CRONENBERG ha diretto due film, di cui The Shrouds è il secondo. È una nuova fase del suo cinema nel quale ogni obbligo narrativo viene decostruito per lasciare spazio ad altro. A cosa? La saggistica.
Se si guarda TS come un film-saggio un senso lo si trova. In caso contrario è difficile non togliersi dalla testa l’idea di una pellicola profondamente autoreferenziale e priva di particolari elementi di interesse.
C’è tutto ciò che ci si aspetta da Cronenberg in questo film? Sì. Ed è questo il problema.
Più che un film di Cronenberg pare di trovarsi di fronte di un film alla Cronenberg, una copia carbone.
TS è un film verboso, rarefatto, discontinuo, pieno di false piste narrative che non conducono a nulla di concreto, a cominciare dalla cospirazione contro i “sudari” di Vincent Cassel.
Non c’è reale trama né sviluppo narrativo, sebbene le premesse suggeriscano il contrario. Neanche il finale è un finale. Si gioca un po’ al ribasso, confondendo la realtà col sogno in maniera fiacca e furbesca, quasi a suggerire che Cronenberg non sapesse dove andare a parare e avesse diretto la prima cosa che gli veniva in mente.
Poiché, però, si parla pur sempre di un autore con una visione di se stesso molto chiara, forse risulta limitante fermarsi a questo.
Cronenberg parla di avatar e se ne costruisce uno (anche a livello estetico) che gli permetta di indagare un concetto: la rielaborazione della morte.
Il film è legato visceralmente con la vita del suo autore e con la morte della moglie avvenuta prima delle riprese – la seconda consorte, Carolyn Zeifman, è stata legata al regista canadese dal 1979 al 2017, anno del decesso.
Ma al contrario di The Brood (1979), che rielaborava il divorzio di Cronenberg dalla prima moglie puntando tutto sulla rabbia, qui si ragiona sulla perdita attraverso l’approccio concettuale.
Il film, dunque, diventa un insieme di immagini intercambiabili tra loro, dove conta la domanda e non la risposta.
Che le istanze narrative non siano prioritarie lo si intuisce anche dalla forma, con continue stonature legate al montaggio e ai raccordi interni alle sequenze – la scena iniziale al ristorante è piena zeppa di errori di posizione degli attori nei campi e controcampi. Si può pensare all’errore involontario. Ma forse è solo un segnale di una voluta oscurità interpretativa a cui si è vocato il nostro autore. Il problema è che non se ne ha certezza. Resta in sospeso il senso di quest’operazione.
Cronenberg è stato abile ad anticipare molte deviazioni contemporanee, dalla dipendenza dai mezzi mass-mediali (Videodrome, 1983) alla disconnessione tra realtà e virtualità (eXistenZ, 1999). In questi film la profezia elevava la messa in scena a manifesto della distruzione. Questa era la potenza dei film di Cronenberg, ancora attuale.
Oggi, TS, cosa ci dice? Sostanzialmente nulla nei contenuti, semmai qualcosa sulla forma.
Ma con un pizzico di filologia cinematografica basta andare al 1973 e rivedere F for Fake di Orson Welles per ragionare sulla “saggistica della visione”.
Peccato.
...segui Gianpietro.
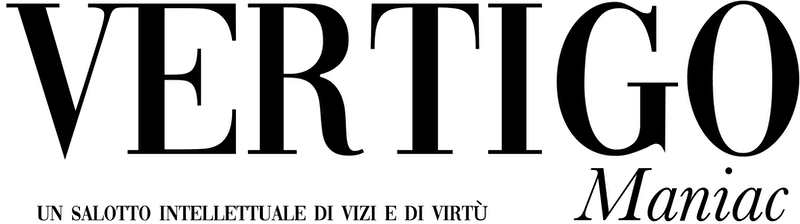



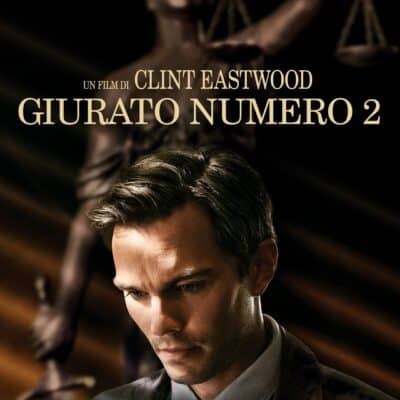


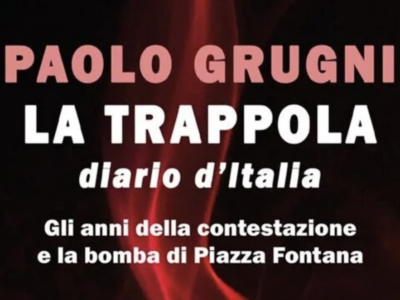


Commenti