Precisione numero 1
Terminata la proiezione del film uno spettatore seduto la fila dietro la mia ha esclamato: “il finale è proprio una merda”. L’ho trovata una frase illuminante perché mi ha confermato come Eastwood avesse colpito nel segno. Di nuovo.
Arrivato a 94 anni, Eastwood ha detto tutto ciò che aveva da dire, quindi, ora, in quello che probabilmente è e sarà il suo ultimo film (da regista), preferisce dare importanza al non-detto.
Giurato numero 2 è un film che gioca le sue carte migliori sui silenzi, su ciò che sta fuori dallo schermo, su quello che potrebbe capitare, o che sarebbe potuto capitare, costruendo una storia classicissima da legal-thriller per parlare di altro.

Di cosa? Di tutto ciò che non funziona nel sistema giudiziario degli USA.
Eastwood crede nel suo Paese, non hai mai nascosto la propria militanza nel partito Repubblicano (militanza che ha pagato con l’umiliazione di essere distribuito con questo film in 50 sale, manco fosse un indipendente, per non finire direttamente in streaming, da una Warnes Bros che ha puntato tutto su Joker 2, ignorando lo status autoriale del regista coinvolto e i decenni di collaborazione alle spalle), e non gli va giù che l’idea di “giustizia” non corrisponda col concetto di “verità dei fatti”. Eppure è così che stanno le cose.
Si potrebbe considerare (a torto) questo film come una specie di costola di Match Point (2005) di Woody Allen ma sarebbe superficiale. Eastwood non è disilluso dalla vita, né si affida al caso per risolvere le diegesi (elemento fondamentale nella pellicola di Allen).
Per Eastwood bene e male sono scelte, spesso complicatissime, che le persone prendono in base a ciò che reputano più utile per loro, ma che non per questo eliminano l’idea di base che una dicotomia esista e sia ben chiara.
Quindi la vicenda di Justin Kemp (uno straordinario Nicholas Hoult) si snoda prima di tutto in un’odissea personale e poi in un dramma legale.
Per un’ora Eastwood ci obbliga a guardare a 360° la vita di Kemp, indagandone il dissidio morale per la (presunta?) colpevolezza dell’omicidio su cui deve ironicamente esprimere un verdetto che può condannare un innocente, mostrandoci una persona comune, un uomo alle prese coi propri demoni personali (l’alcol) che, per una serie di sfortunate coincidenze, deve decidere se far crollare il suo mondo dicendo la verità o se tenerlo in piedi mentendo.
Il “caso” si ferma presto a un evento mai mostrato direttamente, solo accennato.
Perché il fulcro della storia non è cosa sia successo al di fuori di Kemp, ma come lui reagisce alla cosa, come cioè decide di volgere gli eventi a suo favore sapendo che il peso da pagare è l’ergastolo di un innocente.
In questo Eastwood lascia che a parlare siano le immagini e non le parole. Sembra una contraddizione per un film dove la parola, onnipresente, modula il ritmo narrativo, ma gli snodi fondamentali della pellicola sono nelle immagini, nei flashback (eleganti, semplici e diretti), in tutto quello, cioè, che è dato per scontato ma che si carica di una forza nuova e diversa.
A guardarle con attenzione le decisioni fondamentali dei personaggi non sono mai mostrate: la morte di Kendall è ripresa dall’interno dell’auto di Justin; la condanna di Sythe da parte della giuria è lasciata fuori campo; il finale è sospeso, con l’ultimo confronto tra Justin e il procuratore Killebrew senza che i due si dicano una parola dopo aver parlato per due ore.
Ma è un errore pensare che Eastwood abbia una sguardo distaccato; Eastwood ha uno sguardo morale dai tratti chirurgici, ma non ti dà la pappa pronta, né ti imbocca le risposte.
Eastwood usa il mezzo cinema per farti arrivare da solo, da spettatore, alle conclusioni, e se non ci arrivi, be’, cazzi tuoi.
Il “finale di merda” di cui parlava il mio compagno di sala è un finale volutamente privo di consolazioni perché la consolazione, nella vita reale, dunque non nella simulazione delle medesima che è il cinema, non è a portata di mano a tuo piacimento, né, spesso, è proprio presente.
Questo, però, non significa che il nichilismo o il cinismo più becero siano la risposta.
Eastwood crede nella giustizia, crede in un’idea di “verità”, ma ha capito, e tenta di dirti, che le cose in sé non bastano; conta ciò che puoi dimostrare e ciò che scegli. E spesso ciò che scegli è sbagliato e ciò che dimostri è falso.
In questo Eastwood si prende un rischio, sembra andare contro l’idea di “tradizione e ordine” che è propria della sua stessa ideologia politica, ma in realtà la ribadisce da una prospettiva diversa, non per questo in antitesi col film che ti mostra.
E la ragione di tale scelta è dare allo spettatore la possibilità di scegliere senza scadere nell’approccio reazionario.
Perché Justin Kemp, con le sue debolezze e fragilità, col suo opportunismo, con la sua empatia, potresti essere propri tu che, seduto in un cinema, pensi che non spiattellarti sul muso una morale definita significhi non aver trovato la quadratura del cerchio.
Ma solo perché non ti è chiaro che, se chiedi una risposta a una persona e questa tace, una risposta, in realtà, te l’ha già data.
...segui Gianpietro.
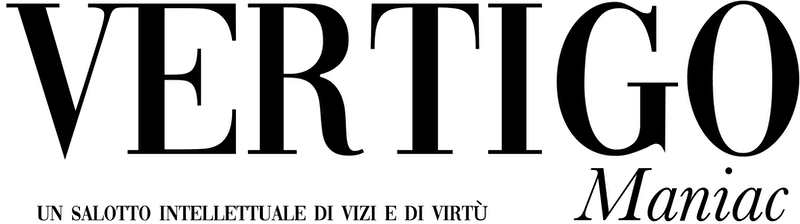
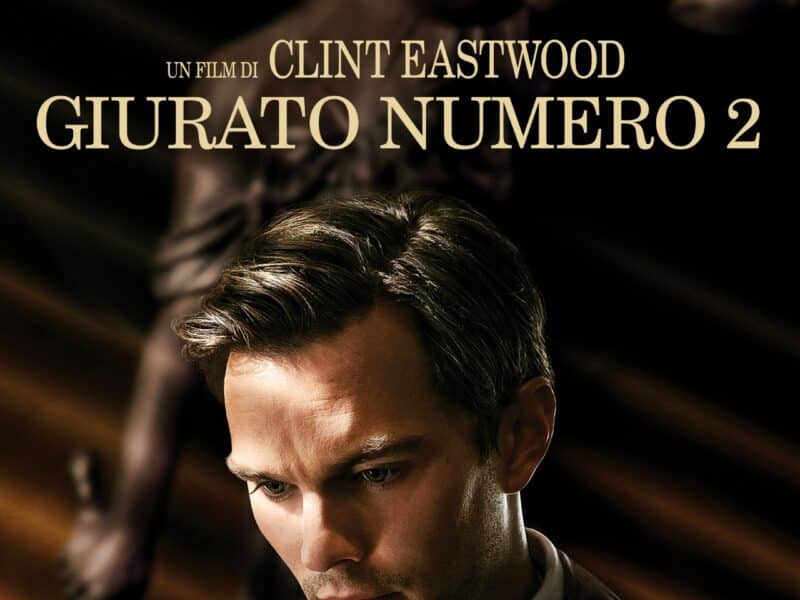







Commenti