Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l’ultima volta in mezzo a noi.
Ricordo come fosse oggi.
Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d’Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno, e la nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a quell’ora, nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda, venuta dalla poco mattiniera Corte di Francia, d’andare a desinare a metà del pomeriggio.
Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: – Ho detto che non voglio e non voglio! – e respinse il piatto di lumache. Mai s’era vista disubbidienza più grave. A capotavola era il Barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, con la parrucca lunga sulle orecchie alla Luigi XIV, fuori tempo come tante cose sue.

Tra me e mio fratello sedeva l’Abate Fauchelafleur, elemosiniere della nostra famiglia ed aio di noi ragazzi. Di fronte avevamo la Generalessa Corradina di Rondò, nostra madre, e nostra sorella Battista, monaca di casa. All’altro capo della tavola, rimpetto a nostro padre, sedeva, vestito alla turca, il Cavalier Avvocato Enea Silvio Carrega, amministratore e idraulico dei nostri poderi, e nostro zio naturale, in quanto fratello illegittimo di nostro padre.
Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i dodici anni ed io gli otto, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori; ossia, io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo, perché non vollero lasciarmi di là a mangiare da solo.
Dico beneficiato così per dire: in realtà sia per Cosimo che per me era finita la cuccagna, e rimpiangevamo i desinari nella nostra stanzetta, noi due soli con l’Abate Fauchelafleur.
L’Abate era un vecchietto secco e grinzoso, che aveva fama di giansenista, ed era difatti fuggito dal Delfìnato, sua terra natale, per scampare a un processo dell’Inquisizione. Ma il carattere rigoroso che di lui solitamente tutti lodavano, la severità interiore che imponeva a sé e agli altri, cedevano continuamente a una sua fondamentale vocazione per l’indifferenza e il lasciar correre, come se le sue lunghe meditazioni a occhi fissi nel vuoto non avessero approdato che a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà anche minima vedesse il segno d’una fatalità cui non valeva opporsi.
I nostri pasti in compagnia dell’Abate cominciavano dopo lunghe orazioni, con movimenti di cucchiai composti, rituali, silenziosi, e guai a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il più lieve risucchio sorbendo il brodo; ma alla fine della minestra l’Abate era già stanco, annoiato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua a ogni sorso di vino, come se soltanto le sensazioni più superficiali e caduche riuscissero a raggiungerlo; alla pietanza noi già ci potevamo mettere a mangiare con le mani, e finivamo il pasto tirandoci torsoli di pera, mentre l’Abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi pigri: – … Ooo bien!… Ooo alors!
Adesso, invece, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell’infanzia.
* illustrazioni di Roger Olmos
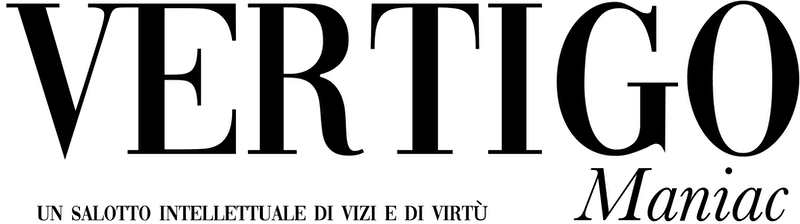







Commenti